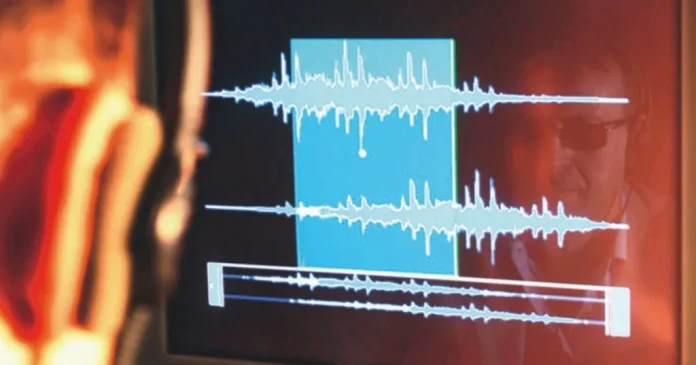(di Paolo Frosina e Antonella Mascali – ilfattoquotidiano.it) – L’ok arriva quasi a mezzanotte, dopo una maratona di oltre sei ore: con i sì di tutto il centrodestra (Azione e Italia viva non hanno votato), mercoledì la Camera ha dato il via libera definitivo alla tagliola alle intercettazioni. È la seconda riforma di peso portata a casa dalla maggioranza in tema di giustizia penale, dopo la legge Nordio che ha abolito l’abuso d’ufficio e sterilizzato il traffico di influenze. Il testo, firmato dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin – ma riscritto da un emendamento dettato dal governo – è composto da un solo articolo: gli ascolti dei pm, si legge, non potranno avere “una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione”.
Cosa cambia, quindi? Attualmente non ci sono limiti all’estensione delle intercettazioni: il pm le chiede e il gip può concederle per periodi successivi di 15 giorni, “quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”. Con la nuova legge, dopo i primi 15 giorni saranno possibili al massimo due proroghe (per un totale di un mese e mezzo) a meno che la Procura non porti al giudice “elementi specifici e concreti” per dimostrare la necessità degli ascolti oltre questo termine. Un ostacolo non da poco, perché – come insegnano gli addetti ai lavori – nelle indagini complesse spesso 45 giorni non bastano nemmeno a orientarsi: “Tra i venti e i trenta giorni occorrono solo per individuare quali sono i telefoni realmente in uso e quelli che invece non servono”, aveva spiegato il procuratore di Roma Francesco Lo Voi, denunciando che la norma equivale in pratica a un “divieto di indagare”. Mentre Roberto Scarpinato, ex pm antimafia e ora senatore 5 Stelle, ha ricordato come possano servire anche quattro mesi per capire il linguaggio della criminalità. Si rischiano poi conseguenze paradossali, come nel caso dei sequestri di persona: “È come se dicessimo ai rapitori di non chiedere il riscatto per i primi 45 giorni, ma aspettare il 46esimo”, ha avvertito in audizione il pm di Foggia Enrico Infante.
La nuova legge però non varrà per tutte le indagini. La norma prevede un’eccezione pensata per i reati di mafia e terrorismo, come hanno detto in Aula i parlamentari di centro-destra. Ma questa deroga avrà una conseguenza, probabilmente non voluta dalla maggioranza: l’esclusione dal tetto dei 45 giorni varrà anche per i delitti contro la pubblica amministrazione: corruzione, concussione e peculato. Vediamo perché. La norma Zanettin “salva” dalla tagliola i reati indicati in una legge del 1991, che contiene la disciplina speciale delle intercettazioni per i reati “di criminalità organizzata”. Il “problema” (per la destra) è che una successiva legge del 2017 ha esteso l’applicazione di quell’articolo ai delitti contro la pubblica amministrazione puniti con una pena massima non inferiore a cinque anni, tra cui corruzione e simili. A sottolinearlo in audizione è stato Gian Luigi Gatta, ordinario di Diritto penale all’Università Statale di Milano, che ne ha parlato anche in un’intervista al nostro giornale.
Se l’obiettivo della maggioranza era fornire un assist ai tangentisti, la legge nasce difettosa. Un errore di distrazione? Probabilmente sì. Mentre per i colletti bianchi non cambierà nulla, il limite di 45 giorni, infatti, azzopperà le indagini sui reati di criminalità comune, compresi quelli introdotti dallo stesso centro-destra: i rave party, l’aggressione ai medici o ai poliziotti, l’occupazione abusiva di immobili. E soprattutto il femminicidio, varato in pompa magna con un disegno di legge presentato appena due settimane fa.
Durante la discussione alla Camera, poi, il governo ha accolto un ordine del giorno presentato dal deputato di Forza Italia Tommaso Calderone, impegnandosi a limitare l’utilizzabilità delle intercettazioni riguardanti terzi, cioè quelle in cui due o più persone – non sapendo di essere ascoltate – parlano di presunti reati commessi da altri: secondo Calderone, per usarle come prova, i magistrati dovrebbero avere l’obbligo di trovare riscontri, cioè elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni captate. Esempio: se Tizio e Caio, intercettati per accuse di droga, parlassero tra loro di Sempronio indicandolo come loro complice, non sarebbe possibile arrestarlo sulla base di quelle frasi, ma bisognerebbe trovare conferme da altre fonti, anche se Tizio e Caio sono perfettamente attendibili.