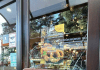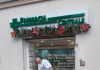Peppino, i passi lenti di un popolo che ha perso
di Gioacchino Criaco
Peppino ha perso i passi finiti chissà dove, in quale luogo, oltre l’acciottolato arrossato di un binario disperso quanto i luoghi che avrebbe dovuto unire.
Ci sono cose, gesta che “non sono belle per quello che potrebbero diventare, per il luogo da cui arrivano, sono belle lì, in quel momento perché sono così, sospese, appena sfiorate” (Borges).
Dopo, oggi, quei passi avrebbero girato, girerebbero, a vuoto, incapaci di trovare una casa del male che personifichi tutto il male del posto, che lo metta tutto intero intorno alla tavola di Tano Seduto, che scinda il futuro dalla melassa.
Lui, il popolo, hanno perso. Abbiamo perso tutti quelli che hanno creduto di poter costruire un ponte fra due universi umani e unire il meglio e il meglio.
E’ il male che, come sempre, ha saputo resistere, avanzare, azzerare speranze.
I fantasmi siamo noi, loro sono diavoli ma comandano.
Oggi Peppino si stancherebbe a furia di fare passi, scriverebbe lettere come un colonnello qualsiasi lungo un sentiero infinito, lettere per cui non troverebbe più neanche una cassetta postale nella quale imbucarle.
Il mondo, nel frattempo, è diventato contrada, i paesi si sono immolati collassando uno sopra l’altro, il nemico s’è fatto nebbia si è mischiato al respiro per entrare in infiniti e insospettabili polmoni.
Nel bene e nel male si sono dissipati i punti di riferimento come chicchi di grandine grossa quanto uova nel colpire e poi dissolti al suolo.
Il Sud non ha più padri da ammazzare, le parole dei figli, buone per abbattere, si sono infilate nelle valigie, si abbatteranno contro muri lontani, dove non le capirà nessuno.
Più delle rivoluzioni il potere teme le derisioni: la presa in giro, l’ironia, la satira. A Peppino non fu perdonato il sorriso. Un sonoro vaffa, non di quelli banali, qualunquisti, retorici, un vaffanculo che veniva dalla profondità della pancia di un popolo che lentamente, pervicacemente riaffermava la malvagità ma anche il ridicolo del potere.
Non era contro la mafia, di più, era contro la sopraffazione di un sistema ingiusto. Svelava la pochezza come uomini dei capi, il loro asservimento al sistema. L’essere l’apparato criminale il servo armato della parte sbagliata del mondo, il comando.
Tano Seduto è la parodia per contrappasso di un eroe autentico, di un figlio del popolo che si oppone al genocidio, Toro Assiso.
Peppino fa cento passi per abbattere Tano con una battuta, per svelare l’inganno, dirgli che stava con gli altri, non con il paese, che serviva il potere, che era un traditore del popolo.
Oggi non avrebbe avuto vita facile, avrebbe dovuto sottoporsi all’esame dell’antimafia con la carta da bollo, visti i pregressi probabilmente sarebbe stato bocciato, relegato per nascita nel campo avverso o inchiodato nel limbo del sospetto.
Rappresenta la resistenza vera, quella che sa riconoscere il nemico ovunque sia: a cento passi, a cento chilometri, a pochi centimetri dal proprio viso o intriso nel boccone che si manda giù a pranzo. La resistenza che non fa la morale, che giudica. La coscienza di un popolo certo della presenza di un nemico che ci sta accanto, dentro.
Si sarebbe potuto vincere con le conversioni invece il moralismo ha alimentato le cacciate, ha fatto vincere gli altri.
C’è il popolo e il potere: il potere produce solo potenti, i popolo figlia i Tanu e i Peppino, il tradimento e la lotta.
Peppino era un camminatore instancabile vivo ancora nel passaggio di testimone. Un podista contro l’ingiustizia che cova ancora nel sistema che muta i Tanu con altre figure ma continua sempre ad avere bisogno di qualcuno che dall’interno tradisca.
Di Peppino era insopportabile la lucidità nel capire e nel deridere, di convertire gli altri e sapersi convertire.
Ha perso, abbiamo perso, è riuscito solo ad aprire una piaga inguaribile nel petto di Felicia.