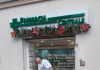Manganelli, bugie e insabbiamenti: così moriva 20 anni fa Federico Aldrovandi, picchiato da 4 poliziotti. «Lo abbiamo bastonato di brutto»
di Valentina Santarpia – Fonte: Corriere della Sera
Oggi Federico, all’epoca 18enne, avrebbe compiuto 38 anni. Il padre: «I nostri sogni spazzati via dalla pazzia criminale degli uomini». Le telefonate al 113, le manette e le botte: la storia dall’inizio
Il telefonino di Federico Aldrovandi squilla a vuoto su una panchina la mattina del 25 settembre 2005. Il suo corpo giace tumefatto, sdraiato supino sull’asfalto, con le braccia allargate che disegnano una croce, così come lo ha mostrato Filippo Vendemmiati nel suo bel documentario, È stato morto un ragazzo. Il papà Lino lo sta aspettando con angoscia, quando intorno alle 11 del mattino vede arrivare due poliziotti al cancelletto di casa. Non è un bel segnale. Chiede, a bruciapelo: «È morto?». E loro non dicono di no.
Sono trascorsi quasi vent’anni dalla morte di Federico, 18enne di Ferrara, incensurato, disarmato, che il 17 luglio 2025 avrebbe compiuto 38 anni. Nonostante la verità giudiziaria sia stata stabilita- e siano stati condannati quattro poliziotti a tre anni e sei mesi per omicidio colposo per eccesso di mezzi di contenimento- la vicenda di Federico resta una ferita aperta per il Paese, ed è diventata il simbolo di una battaglia culturale dolorosa e complessa, sollevando interrogativi brucianti sul ruolo delle forze dell’ordine e sulla gestione della sicurezza.
«Tanti giovani studenti, ben educati, di buona famiglia, incensurati e di regolare condotta, con i problemi esistenziali che caratterizzano i diciottenni di tutte le epoche, possono morire a quell’età – scrive il giudice Francesco Maria Caruso nelle motivazioni della sentenza – Pochissimi, o forse nessuno, muore nelle circostanze nelle quali muore Federico Aldrovandi: all’alba, in un parco cittadino, dopo uno scontro fisico violento con quattro agenti di polizia, senza alcuna effettiva ragione».
La storia di Federico Aldrovandi, dall’inizio
Federico è un ragazzo come tanti in quel 2005: nato a Ferrara il 17 luglio 1987, frequenta l’Itis elettronica, ha molte passioni, tra cui il calcio (tifoso della Spal), la musica e le arti marziali. Suona il clarinetto e pratica karate fin da bambino. Inoltre, si è impegnato in un progetto scolastico per la prevenzione delle tossicodipendenze. In attesa di sostenere l’esame per la patente, svolge occasionalmente lavori come pony express in una pizzeria.
La sera del 24 settembre esce con gli amici di sempre, quelli con cui si vedeva a scuola, ma anche «nella stessa compagnia», come si diceva allora. «Una serata tranquilla», racconta dopo anni uno dei suoi più cari amici. Erano andati a vedere un concerto reggae al Link, un centro sociale all’aperto, «abbiamo riso, scherzato, una serata normalissima: era ancora caldo, un po’ di musica, qualche birra, si stava bene».
Gli esami tossicologici diranno che Federico aveva modeste quantità di alcol e droga nel sangue, sostanze rilassanti, non eccitanti. Al ritorno in auto Matteo Parmegiani guida, Aldo Boldrini è «copilota», dietro ci sono due ragazze e in mezzo «Aldro», sulla strada di ritorno cantano e parlano, Federico è attivo e sveglio.
Poi si addormenta quando loro si fermano all’autogrill per prendere qualcosa da mangiare. «Siamo passati davanti a casa sua e Matteo gli ha chiesto se voleva che lo lasciassimo a casa, ma lui ha detto che avrebbe preferito venire con noi e fermarsi al parchetto per poi andare a fare colazione. L’ultima volta che l’abbiamo visto è stato quando lo abbiamo lasciato al parchetto, camminava in direzione via Bologna, una traversa di via Ippodromo», racconta Boldrini nel podcast Rumore di Francesca Zanni.
Sono le 5 del mattino: Federico scende al parcheggio delle scuole elementari Tumiati, come faceva spesso perché amava fare quattro passi prima di rientrare a casa. Tra le 5 e le 5,20 Federico fa nove telefonate, tutte ai suoi amici, più o meno intimi: ma nessuno gli risponde. Stava cercando aiuto? Nessuno lo saprà mai. L’ultima telefonata la fa alle 5.23, da quel momento c’è un buco di mezz’ora: quello che succede in quel lasso di tempo è stato solo in parte chiarito.
Cos’è successo la mattina del 25 settembre 2005

Alle 5.48 una residente di via Ippodromo, Cristina Chiarelli, che sta per uscire per andare a lavoro, chiama i carabinieri per avvisare che c’è «uno che sta andando in escandescenza, sta urlando come il matto: non ho capito se sono uno o due, è nascosto dagli alberi. Le voci vengono da lì», dice parlando al plurale. Chiarelli dice anche di aver sentito la persona urlare parolacce, come «gente di merda».
Il centralinista, nel passare la comunicazione alla polizia, dice che c’è una persona che sta sbattendo la testa contro i pali, facendo intuire che stia adottando gesti di autolesionismo. Una versione che Chiarelli poi smentirà in tribunale.
Di testimonianze ce ne sono altre. Massimiliano Solmi avrebbe iniziato il suo turno a bordo di un’autombulanza del soccorso pubblico alle sei di quella mattina. Il deposito delle autombulanze è proprio nella via dove sta avvenenendo il trambusto. Rendendosi conto che sta accadendo qualcosa, sentendo qualcuno urlare «bastardi», si affaccia per capire cosa stia succedendo. Si tranquillizza perché vede una macchina della polizia.
Anche Christian Fogli, che abita in via Poletti, ma ha le finestre su via Ippodromo, si allarma perché teme che i rumori possano svegliare sua figlia neonata: parla di un ragazzo in stato di semi ubriachezza che sta urlando, e al numero di emergenza gli rispondono che una volante sta già intervenendo. Probabilmente parla di Alpha 3, la volante con a bordo Enzo Pontani, capo pattuglia, e Luca Pollastri.
Poco dopo arrivano i «rinforzi», la volante Alpha 2, composta da Monica Segatto e Paolo Forlani. Sul luogo arrivano anche i carabinieri. Alle 6.04 i poliziotti chiamano un’ambulanza, che arriva poco dopo, seguita da un’auto medica. Gli operatori dell’ambulanza trovano Federico sdraiato sulla strada, in posizione prona, i polsi ammanettati dietro la schiena. È immobile, eppure – raccontano i carabinieri – i poliziotti sono ancora inginocchiati per cercare di tenerlo fermo. A questo punto Federico con ogni probabilità è già morto.
Il corpo sull’asfalto

I sanitari chiedono ai poliziotti di rimuovere le manette e girare il ragazzo per effettuare le manovre di rianimazione. Purtroppo qualsiasi tentativo è vano. Nel frattempo la famiglia non sa nulla. Il padre, Lino, agente della polizia municipale, che con la moglie Patrizia Moretti, figlia di un carabiniere, ha condotto una lunga battaglia per ottenere giustizia, ha scritto: «Il 25 settembre di ogni anno, giunta l’alba, si ripete quello che per me rimarrà per sempre un incubo, o peggio, il ricordo orribile dell’uccisione di un figlio da parte di chi avrebbe dovuto proteggergli la vita».
È proprio Lino a chiamare il cellulare del figlio, quella maledetta mattina, quando gli risponde l’ispettore che ha accanto a sé il corpo sanguinante di Federico: «Lei chi è?». «Chi è lei? – ribatte Lino Aldrovandi – Perché risponde al cellulare di mio figlio?». L’ispettore non gli dice nulla, gli chiede di descrivere il figlio.
«Avrei dovuto capire che mi stava chiedendo di descrivere mio figlio che era lì, ma non mi è venuto – racconta Lino – e quindi mi ha rimesso giù, mi ha detto: le faremo sapere. Abbiamo continuato a chiamare gli ospedali. Poi abbiamo chiamato un amico della Digos, che non era a casa perché quel giorno era stata chiamata tutta la Questura lì, tranne il magistrato, la dottoressa Maria Emanuela Guerra». È la pm che poi chiese di essere sollevata dall’incarico perché insinuarono che non potesse essere imparziale, essendo figlia di un operatore della Polizia di Stato.
«Federico? È morto?»
Il fratello minore di Federico, Stefano, esce in bicicletta a cercarlo, ma va dalla parte sbagliata, e non vede nulla. Il corpo di Federico rimane steso sull’asfalto, senza un lenzuolo, per ore, e senza che la famiglia sappia cosa gli sia successo. A riconoscere Federico è un funzionario amico di famiglia, Nicola Solito, ispettore di polizia di Ferrara. È proprio lui a presentarsi poi insieme a due poliziotti al cancelletto di casa Aldovrandi, lui a tacere abbassando gli occhi quando Lino gli chiede: «Federico? È morto?».
Entrano in casa, il papà cade in ginocchio disperato, gli chiede perché. Solito risponde che c’è stato uno scontro con dei colleghi. «Si sono fatti male?», chiede Lino nell’incoscienza del momento. L’amico risponde di no, che Federico aveva perso la testa, era quasi impazzito, era salito sul tetto della macchina, gridava, «sbatteva contro i pali». La stessa ricostruzione che il centralinista aveva dato alla polizia. Ma la scientifica non ha mai trovato riscontro.
Giovanardi: «Un eroinomane»

La prima ipotesi fatta circolare all’epoca sulla morte di Aldrovandi presupponeva un malore, causato da un mix di alcol e droghe assunto durante la serata. Il ministro Carlo Giovanardi, in risposta ad una interrogazione parlamentare, parlò di Federico come di un «eroinomane». Lo stesso Giovanardi verrà poi denunciato per diffamazione aggravata dalla famiglia qualche anno dopo quando, parlando della foto del volto tumefatto di Federico mostrata dalla madre, disse che non si trattava di sangue ma di un cuscino.
I manganelli spezzati
La prima perizia effettuata accertò da subito la presenza di 54 lesioni ed ecchimosi. Le successive stabilirono che la morte era avvenuta per un arresto cardiaco dovuto a compressione toracica e alle numerose percosse subite, non all’assunzione di sostanze.
Gli agenti hanno sostenuto durante i processi la tesi per cui il ragazzo fosse in stato di agitazione e avesse tentato di aggredirli. Accanto al suo corpo, quella stessa mattina, furono trovati due manganelli spezzati a metà, di cui parlò per la prima volta Giovanardi. Non sono mancati, negli anni dell’iter giudiziario, querele, denunce e insulti tra le parti, ma alla fine la giustizia ha stabilito la colpevolezza dei poliziotti.
Nel marzo 2006, i quattro agenti coinvolti – Monica Segatto, Paolo Forlani, Enzo Pontani e Luca Pollastri – vennero iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. Nel 2007, il professor Gustavo Thiene dell’Università di Padova confermò che Federico era morto per asfissia da compressione toracica, provocata dal peso esercitato dagli agenti sul suo corpo.
Nel 2009, il tribunale di Ferrara ha condannato i quattro poliziotti a tre anni e sei mesi di carcere, per omicidio colposo ed «eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi». La Corte d’Appello e la Corte di Cassazione hanno confermato la sentenza nel 2011 e nel 2012. I giudici hanno stabilito che la morte di Aldrovandi è stata causata dalle percosse subite quando era già ammanettato.
Sei mesi di carcere
La pena è stata in seguito ridotta a soli sei mesi per l’indulto. Nel 2010 viene stabilito il risarcimento di due milioni di euro nei confronti della famiglia di Aldrovandi. In quello stesso anno la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza emessa in primo grado.
Nel 2013, Monica Segatto ha ottenuto i domiciliari dopo due mesi di detenzione. I quattro agenti sono rientrati in servizio nel febbraio del 2014, seppure in ruoli amministrativi. Nel processo Aldrovandi bis, quello aperto per depistaggi, sono stati condannati anche Paolo Marino, dirigente dell’Upg all’epoca, a un anno di reclusione per omissione di atti d’ufficio, per aver indotto in errore il pm di turno non facendola intervenire sul posto; Marcello Bulgarelli, responsabile della centrale operativa, a dieci mesi per omissione e favoreggiamento; Marco Pirani, ispettore di polizia giudiziaria, a otto mesi per non aver trasmesso, se non dopo diversi mesi, il brogliaccio degli interventi di quella mattina.
In Cassazione i familiari di Federico Aldrovandi non si costituirono parte civile, avendo raggiunto una transazione col ministero dell’Interno e ricevuto le scuse del capo della Polizia Antonio Manganelli, che incontrò i genitori del giovane durante una visita privata. Ma in tutti questi anni i genitori non hanno mai smesso di lottare per far conoscere la storia del proprio figlio.
Al caso sono stati dedicati film, documentari, podcast, canzoni, convegni, eventi, libri, tra cui «Federico», quello dell’avvocato Fabio Anselmo, che si è occupato del caso e anche di quello di Stefano Cucchi. Anselmo racconta che all’inizio non poteva credere che fossero stati proprio i poliziotti a ridurlo in quelle condizioni, che aveva paura di andare avanti su quella strada perchè aveva dovuto lasciare lo studio per diversi mesi per motivi personali, che si sentiva sprovveduto a dover affrontare una questione così grave. «Mi convinse la mia socia – racconta nel podcast Rumore – Mi disse: ma se non facciamo casi così, che facciamo a fare gli avvocati?».
La zona del silenzio
Davanti al cancello dell’Ippodromo di Ferrara, vicino al luogo dove è morto Federico, c’è un cartello con scritto «Zona del silenzio», che si riferiva alla necessità di non fare rumore per non disturbare i cavalli. Ma che ha acquisito un significato simbolico della vicenda Aldrovandi, ricordando il silenzio che inizialmente avvolse la morte del ragazzo.
La madre, Patrizia Moretti, aprì un blog nel gennaio del 2006 che scosse le coscienze: la sua lettera di denuncia raccolse un migliaio di commenti in pochi giorni, un record per quel periodo. Molti di quei commenti venivano da chi aveva sentito e capito, quella mattina, e che grazie a quella richiesta, trovò la forza e il coraggio di denunciare.
Iniziò a farsi strada solo allora, quattro mesi dopo la morte, l’ipotesi che Federico fosse morto durante l’intervento degli agenti: dai racconti emergeva che Federico fosse rimasto a lungo a terra, con almeno un poliziotto sulla schiena, che aveva difficoltà respirare e chiedeva invano di essere aiutato.
La lettera venne ripostata su Indimedia, un portale a libero accesso, dove gli attivisti potevano postare notizie in maniera indipendente. Grazie alla diffusione di quel post si interessò della vicenda anche Amnesty International, che poi nell’ottobre del 2018 avrebbe lanciato una campagna per chiedere l’introduzione, anche in Italia, di codici identificativi sulle uniformi e sui caschi degli agenti impegnati in attività di ordine pubblico.
E laddove le fonti ufficiali avevano nascosto, edulcorato, insabbiato, la scelta della famiglia e dei legali di dare piena visibilità a quanto accaduto a Federico cambiò completamente il corso delle indagini e della percezione pubblica di una cittadina di provincia. La fotografia di Federico massacrato che venne pubblicata per scelta dell’avvocato, con i segni dei manganelli sul volto e la macchia di sangue che si allargava sul lenzuolo bianco sotto di lui, fu un vero choc.
E anche chi aveva paura di parlare si convinse: come Anna Marie Tsangue, una donna camerunese di 35 anni che aveva il permesso di soggiorno in scadenza, che in una prima fase disse di non aver visto nulla, poi si confidò col suo parroco e poi con un legale. Fu uno dei testimoni fondamentali in tribunale per raccontare quanto successo: «Quattro di loro su di lui che lo picchiavano», un brutale pestaggio da parte degli agenti di polizia, nato da un diverbio, come raccontò un altro testimone a Chi l’ha visto, nato chissà per quale motivo.
Le testimonianze del pestaggio furono tante nel corso del processo ma una delle più rilevanti fu proprio quella di uno degli imputati, Enzo Pontani, che la mattina del 25 settembre nel chiamare in centrale disse: «Una lotta di mezz’ora con questo qua… lo abbiamo bastonato di brutto… ora è svenuto, mezzo morto». Federico probabilmente era già morto. In tribunale Pontani cercò di farla passare come una metafora calcistica.
L’alba maledetta di un nero settembre
A distanza di quasi vent’anni dalla morte di Federico Aldrovandi, suo padre Lino continua a tenerlo in vita sui suoi social con post strazianti, dove i ricordi si intrecciano con i rimpianti. Per il suo «trentottesimo compleanno» ha scritto: «Saresti qui Federico, questo ci disse il difficile percorso giudiziario che portò alla condanna di chi ti uccise per l’appunto senza una ragione. Ti guardo in una delle tue ultime foto e non posso che pensare a come saresti ora. Stringo forte i pugni e chiudendo gli occhi non posso che immaginare che saresti bellissimo. Lo saresti sia fuori, nell’aspetto, ma soprattutto dentro, nel cuore e nell’anima. Ci sono cose di un figlio che non si possono dimenticare: le carezze, gli abbracci, i tanti “ti voglio bene”, ma anche le tante preoccupazioni di farlo crescere nel miglior modo possibile. E nel tuo caso, in quel 2005, quando tutto sembrava volgere al meglio nella nostra vita famigliare pur nei sacrifici, non avevamo previsto che in un’alba maledetta di un nero settembre, tutti i nostri sogni sarebbero stati spazzati via dalla pazzia criminale degli uomini, di quegli uomini (…)».
«Sono trascorsi ben vent’anni dalla tua morte assurda» prosegue il post di Lino Aldrovandi, «o peggio, dalla tua uccisione assurda, e ho capito che il dolore insopportabile dell’assenza di un figlio, nel tuo caso come di un fiore sradicato dalla terra senza un motivo, in me, tuo padre, non potrà mai trovare pace».