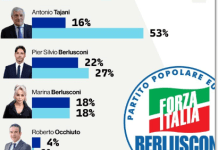Il Natale nei paesi che stanno morendo. Ascoltare i segni di vita e di presenza
di Vito Teti
Fonte: Domani
Cammino, in queste giornate luminose che precedono il Natale, lungo le mie strade di casa e di paese, che mi hanno visto bambino.
Ho 75 anni, e il paese ha meno di mille abitanti; quando ero bambino ne aveva quattromila. Vado a fare visita e a portare piccoli doni natalizi a un parente più grande di me e a qualche amico che è ammalato. È un’eredità, un imperativo, che ho ricevuto da nonna, da mia madre, dalla gente del paese. Certo, è un po’ fuori moda, fuori da questo tempo precario, insicuro, senza certezze.
La “ruga” in cui abito è muta, vuota. A volte, la notte mi sveglio, non conto le pecore, ma cerco di ricordare tutte le persone di quel mondo scomparso: non riesco ad afferrarle, sono partite, fuggite, in ogni parte del mondo soprattutto a Toronto. Tutte le case in cui dovevano tornare quelli che me lo promettevano, mentre ci abbracciavamo piangendo come in un lutto, sono chiuse, non vi abita più nessuno, non conosco più nemmeno i proprietari.
La piazza
Mi dirigo verso la piazza. Non c’è più Maria della Rocca, che mi chiamava per farmi ascoltare i canti e gli stornelli che finivano con una sua contagiosa risata finale; le case di Giovannarosa, di Togliatti, dei Petricelli sono chiuse e, ormai, a ischio crollo.
Non ho nostalgia di quelle case, ma di tutte le persone che vi abitavano, che si affacciavano sulla soglia per salutarmi e offrirmi il caffè, che mi raccontavano mille storie e le vicende di una vita di fatica e di resistenza. Nella piazza, dove non abita più nessuno, c’è qualche arco con piccole lampadine natalizie, un presepe, quello esposto di ogni anno, ha come compagna una fontana che scorre lenta, pigra, quasi con tristezza: forse ricorda le tante e tante persone che un tempo la allietavano con i loro scherzi, le loro serenate, i loro rituali litigi.
Studiosi di ogni disciplina, colleghi impegnati in mille iniziative contro lo spopolamento, hanno tante idee, tanti progetti, molta passione, infinite fantasie e mille menzogne su come “rigenerare” i paesi che si spengono lentamente.
Paesi moribondi
Il fatto è che, dopo mille spostamenti, dopo tanti falsi movimenti, dopo un’illusoria speranza di ritorni a causa del Covid, qui nulla è come prima. Quando i paesi erano ancora vivi, pure se ammalati, e avevano bisogno di cura amorevole, di un riguardo convinto, di una diversa attenzione, i ceti dominanti facevano i loro affari, i gruppi dirigenti, politici e non solo, nazionali e locali, si arrangiavano, gli altri inveivano e speravano, fuggivano.
Dinnanzi al moribondo si è rimasti disarmati, scettici, impotenti. E desso che molti paesi stanno chiudendo, che tutti i paesi delle aree interne d’Italia e delle isole sono a rischio spopolamento, il paese è ancora il luogo dove vivono milioni di abitanti, ma anche un’ossessione, un fantasma. Per alcuni un ammalato il cui spopolamento è inarrestabile, un moribondo da accompagnare con cura alla morte, per altri un luogo da riabitare, da rigenerare, dove restare e resistere. In genere, i paesi non sono guardati nel presente, con le loro pene e le loro illusioni, sono diventati riserva di caccia di esteti delle rovine, di sognatori di un mondo genuino e compatto dove fuggire o nascondersi o dove fare affari e affermare il proprio io.
Non interessa il paese, la sua gente, chi resta, chi parte, chi torna, chi resiste, chi inventa nuova cultura, chi soffre il vuoto e la solitudine, il paese diventa l’ombra delle nostre insoddisfazioni, il borgo puro e incontaminato, dove trovare la felicità, dove fare festival, dove radunare i giovani tormentati e in colpa che vivono nella città e magari nella comodità e la loro escursione fuori le mura, la loro vacanza intelligente, le loro comunità provvisorie, ma effimere.
I paesi in abbandono sono le moderne scenografie degli spettacoli dei mesi estivi, perché d’inverno ognuno si guarda bene dall’andare nei luoghi del freddo e dell’oscurità, dove non ci sono balli, locali per bere o ascoltare musica. I paesi vengono trasformati in mito, in Eden o in luoghi invivibili, impossibili, senza futuro. Abbiamo inventato i paesi dei balocchi, i paesi market, dove con violenza dei social vengono offerti buoni sentimenti al costo di un “euro”.
La verità è che nei paesi non c’è più la gente, il paese è un non più luogo, che non riesce a diventare nuovo luogo, non è più una comunità fatta di relazioni, rapporti, contrasti, condivisioni, riti comuni. In questo clima in cui la fiducia, la speranza, la pace vengono banditi dall’alto, quale scuola di ipocrisia hanno frequentato quelli che inneggiano al “nostro Natale”, alla nostra “religione”, mentre hanno desacralizzato vita, malattia, feste, riti, morte delle persone?
Paese e presepe
C’era una volta il Natale e c’era la comunità, c’era il presepe e c’era il paese. Nessuno meglio della figura dell’incantato del presepe, che guarda assorto e fisso la stella, che annuncia la nascita del Bambinello, può raccontare oggi lo stupore melanconico e utopico delle persone che aspirano alla giustizia niente più di quel personaggio riassume il senso di stupore e di meraviglia delle persone che si trovano di fronte a eventi straordinari ed eccezionali.
La nostalgia del tempo bello e innocente dell’infanzia non porta da nessuna parte, ma, forse, il termine nostalgia va legato all’abbandono di un’idea di storia progressiva”, per cui quello che viene dopo è sempre migliore di quanto è accaduto prima.
La nostalgia non può essere sentimento regressivo, quanto un’emozione e una risorsa per criticare un presente desacralizzato e per affermare un’idea di futuro diverso da quello che ci impone il neoliberismo dominante.
Gli ultimi “resistenti”
Una nostalgia critica, oppositiva, utopica ha un senso anche se sappiamo cogliere la poesia del Natale che, nonostante tutto, permane. Pure in universo rarefatto, ancora oggi nel paese, gli ultimi “resistenti”, i giovani rimasti e tanti studenti o emigrati a Roma, nelle città del Nord, che tornano per fare il Natale a casa o nel paese dei padri e delle madri, cantano e suonano la “novena” (la “strina”) per le vie, e qualcuno apre loro la porta, il cuore, e offre salame, braciole, zeppole, panettone, frutta, vino, bevande, liquore.
Non è un rito del passato, è un rito del presente, di quanti riescono a stabilire un legame tra il mondo di ieri e il mondo di oggi, e continuano a sognare che questo presente possa legarsi al mondo di domani. E questo “spirito” di continuità, di attesa e di speranza che affermano i giovani che camminano nelle strade, cantando «giù dai monti e dalle valli, scorre latte e miele ancora».
Forse, allora, dovremmo continuare a capire l’attesa e l’avvento, a riconoscere il sapore del latte e del miele, a guardare gli “astri del ciel” e immaginare e inventare “altri monti” e “altre valli”, altre vite, altra vita. Anche io nella notte mi dico che, forse, non si tratta soltanto di cambiare sguardo per osservare il “centro” dalle periferie e dai margini, ma di cambiare soprattutto sguardo per considerare diversamente il passato e il tempo presente, per capire, o inventare, che il “centro” è qui e ora, dove resistono, pure tra dolori e difficoltà, almeno il sogno e l’utopia di una nuova comunità.
Forse, come dice Tim Ingold, è il passato a essere davanti a noi, mentre il futuro è alle nostre spalle. Questa visione comporta l’abbandono di una cieca fede nello sviluppo e nella tecnologia, nel neoliberismo, nell’urbanocentrismo e nell’antropocentrismo, come uniche risposte ai problemi dell’umanità.
«L’assai è come il niente»
Il passato andrebbe recuperato, non soltanto come memoria, ma nelle sue potenzialità inespresse, nelle tante vie non percorse, rimosse, cancellate: non va considerato un tempo-luogo dove tornare, ma un universo del presente, dove affermare un altro senso del sacro, una frugalità e una sobrietà che consentano di donare cibo, acqua, terra agli ultimi e così evitare le guerre.
Forse hanno avuto ragione i miei nonni che dicevano che «l’assai è come il niente»: il troppo è inutile, rende infelici, ci trasforma in macchine di consumo, portandoci verso la «fine del mondo» che vorremmo scongiurare. Forse, come avveniva nel Natale del passato, è necessario affermare un mondo alla «rovescia», dove ci sia sempre non un’innovazione “comunque” e a ogni costo, ma la rigenerazione del Mondo, che, a saper sentire, da qualche parte, continua ancora a mandare segni di vita e di presenza.