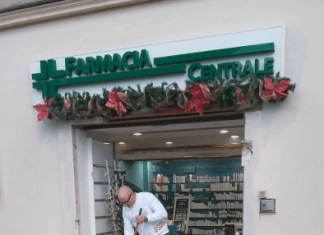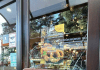di Michele Santagata
Lo ripetono in molti: Dario Brunori è considerato il volto più autentico della nuova canzone d’autore italiana. Un cantautore nel senso pieno del termine, forse il più compiuto della sua generazione. I suoi testi, la sua musica, la sua poetica – sospesa tra ironia e malinconia, tra intimità e disincanto – rievocano, a tratti, i meravigliosi anni in cui i cantautori erano la coscienza del Paese. Ed è proprio questa continuità, questo legame ideale con i maestri del passato, a renderlo oggi una figura così riconoscibile e amata. Perché, come loro, Brunori interroga la realtà e dialoga con la coscienza collettiva. Perché un cantautore non è mai soltanto un musicista: è un cronista morale, un testimone del proprio tempo, una spia dell’inquietudine collettiva, capace di trasformare la vita quotidiana in racconto universale.
Il cantautore, per antonomasia, è l’impegno: non canta per piacere, ma per necessità, perché ogni verso è un modo per restare fedele alla realtà che racconta. E quando parliamo di cantautori, non pensiamo certo a chi si limita solo a cantare l’amore o la nostalgia, ma a chi, con la propria voce, ha saputo mettere in discussione il potere, raccontare le ingiustizie, dare un nome al disagio sociale e politico del suo tempo. È questa, dunque, l’eredità che Brunori sembra voler raccogliere: non quella del cantautore romantico o disimpegnato, ma di chi ha trasformato la musica in una forma di coscienza civile. Un’eredità pesante, che non si può evocare senza misurarsi con chi, prima di lui, ha pagato sulla propria pelle il prezzo della verità. Perché quello del cantautore è un mestiere duro. Almeno lo era, un tempo.
Per i cantautori del passato il palco non era un luogo di intrattenimento, ma un campo di battaglia dove la musica si misurava con la politica, la piazza e la rabbia sociale. Ogni parola, ogni nota, poteva trasformarsi in un atto d’accusa. Non bastava scrivere bene: bisognava anche prendere posizione. Ogni concerto era un corpo a corpo con il pubblico, un confronto reale, teso, che spesso finiva per lasciare ferite da entrambe le parti. Il pubblico non si limitava ad ascoltare: interrogava, pretendeva, giudicava. Voleva sapere da che parte stavi, se le parole che cantavi le vivevi davvero, se dietro la poesia c’era la lotta o solo il privilegio dell’artista. Schierarsi contro il potere, contro l’ingiustizia, contro la povertà, lo sfruttamento era la condicio sine qua non per essere riconosciuti come “impegnati”. Da chi cantava la politica, il sociale, il cambiamento, la rivoluzione si pretendeva un impegno che andasse oltre il palco, oltre la vita comoda e effimera dell’artista. Nella lotta bisognava essere tutti uguali, senza privilegi, senza differenze. E quando la distanza tra le parole e la vita reale sembrava anche solo sospetta, arrivavano le contestazioni. Il pubblico diventava giudice, e il cantautore, da voce del popolo, poteva trasformarsi in bersaglio.
Francesco De Gregori fu processato sul palco del Palalido da chi lo accusava di “fare soldi con la rivoluzione”. Fabrizio De André venne fischiato nel tour con la PFM per la sua “svolta rock borghese e commerciale”. Edoardo Bennato si trovò nel mezzo di una guerriglia tra autonomi e polizia a Palermo, quando i collettivi volevano l’incasso della serata. Guccini veniva attaccato perché troppo professore, troppo intellettuale, troppo poco militante. Lucio Dalla sfiorò una molotov a Milano. Gaber riceveva monetine e insulti dai suoi stessi compagni. Lolli, Pietrangeli, Jannacci: ognuno di loro, in modi diversi, fu giudicato, frainteso, colpito.
Erano altri tempi, è vero. Ma chi sceglie di raccogliere quella pesante eredità del “cantautore impegnato” ha il dovere di non disperdere lo spirito universale che da sempre la accompagna: quella tensione morale che trasforma la musica in un gesto di responsabilità, in un modo di stare al mondo. Perché se allora si cantavano le fabbriche, gli operai, la rivoluzione, oggi non mancherebbero certo le ingiustizie da raccontare: le guerre, la fame, la miseria, la precarietà, l’indifferenza. Le piazze esistono ancora, ma è cambiato il modo di abitarle e, soprattutto, di raccontarle. Oggi il cantautore continua a schierarsi, ma lo fa da una distanza di sicurezza, dietro il linguaggio perfetto della sensibilità contemporanea: civile, empatica, ma innocua. Forse sta qui la differenza più profonda rispetto al passato: oggi il cantautore non rischia più di essere frainteso o contestato; al contrario, è applaudito proprio per la sua misura, per la sua capacità di non turbare. Così la canzone d’autore, da coscienza critica, è diventata carezza identitaria: rassicura invece di provocare, consola invece di scuotere. Non cerca più di cambiare il mondo, ma di farcelo accettare con dolcezza. E Brunori è il simbolo più compiuto di questa metamorfosi: non un’eccezione, ma il suo esito naturale, il punto d’arrivo di un percorso in cui il conflitto ha lasciato spazio alla consolazione e l’urgenza alla misura.
Di quella grande eredità Brunori ha conservato il talento e la sensibilità, ma ha sostituito il valore della protesta con la contemplazione, la piazza con il salotto. La sua responsabilità – o forse la sua astuzia – è quella di aver trasformato la denuncia in malinconia, l’inquietudine in poesia, la rabbia in empatia. Un tempo i cantautori dividevano, oggi conciliano. E Brunori, più di chiunque altro, ha trovato la formula perfetta per mettere tutti d’accordo, per tenere insieme mondi che un tempo si sarebbero detestati: l’ironia.
Dai primi dischi, Brunori ha costruito un personaggio che gioca sull’autodenuncia (“sono un mediocre”, “sono un borghese”) per neutralizzare la critica prima ancora che arrivi. È il meccanismo perfetto dell’autoassoluzione borghese: ride di sé per non dover cambiare sé. Ma la sua, senza offesa, non è l’ironia corrosiva di Gaber o Jannacci, che scarnificavano il proprio tempo. La sua è un’ironia che consola, che non disturba. E in questo sta la sua forza, e il suo limite. Brunori non divide, non spaventa, non pretende: accompagna, accarezza, fa sentire tutti migliori senza chiedere nulla in cambio. È la voce di chi oggi preferisce la comprensione al conflitto, la sensibilità alla rabbia, l’armonia al rischio. Sa riconoscere il punto G del pubblico. E per questo piace a tutti: ai radical chic, ai progressisti tiepidi, ai nostalgici della sinistra che fu, ai preti illuminati, ai comunisti disillusi, ai liberali sentimentali.
Non urta, non disturba. Neanche quando prova a sembrare radicale, invitando il pubblico a manifestare contro il genocidio a Gaza. Conosce la misura, il tono, il limite, e non li oltrepassa mai. Sa fino a dove può spingersi per apparire impegnato, senza mai varcare quella soglia dove l’arte smette di essere conforto e torna a essere coscienza. È la sua idea di equilibrio, educata, rassicurante, politicamente corretta, la vera novità nella musica d’autore o impegnata. Che spezza però il legame con il passato. Oggi l’impegno è diventato linguaggio, non scelta; gesto, non rischio. Il potere non teme più i cantautori, li invita alle cerimonie, li applaude dai palchi, li usa come cornice di sensibilità. E così l’artista che un tempo sfidava il potere con la chitarra, oggi lo accompagna con un sorriso.
Tutto questo può sembrare un argomento da poco, pretestuoso, persino dettato dall’invidia, se volete. Giusto per fare una critica. Ma quella foto in copertina conferma quanto sia cambiato il ruolo del cantautore: da coscienza civile a scenografia del potere. In quella posa non c’è solo il garbo verso le istituzioni, c’è la quieta rinuncia di chi ha scelto di piacere invece che disturbare. Pensate a De André che posa con Andreotti, a Dylan con Nixon, a Guccini con Cossiga. Impensabile. Perché per loro l’impegno non era un hashtag, ma una distanza. Distanza dal potere. Brunori invece la distanza la accorcia, si avvicina, sorride al potere. E in quello scatto c’è tutto: il passaggio da chi sfidava il potere a chi ci posa accanto, con la luce giusta e l’inquadratura perfetta. Brunori è, senza dubbio, il più autorevole esponente dei nuovi cantautori impegnati. Impegnati, sì, ma a non dire mai di no a una foto col potente di turno. Come a dire: l’impegno vale, ma fino ad un certo punto. Tajani docet.
P.S. Se De André, Guccini, Bennato e De Gregori furono contestati, fischiati e persino messi sotto processo dal loro stesso pubblico, allora si potrà pure permettere una critica a Brunori senza gridare allo scandalo. Dopotutto, la mia è una critica garbata: niente parolacce, niente aggettivi offensivi, niente nomignoli o ingiurie. Insomma, una critica educata. Proprio come piace a Brunori.