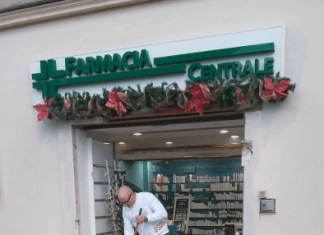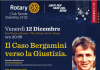Il punto sulla Legnochimica di Rende.
di Matteo Olivieri
La recente interrogazione parlamentare sul caso Legnochimica al Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha confermato ufficialmente ciò che ormai si sapeva da tempo: il Ministero dell’Ambiente non ha alcuna competenza diretta sulla vicenda.
Al massimo può fornire supporto tecnico e verificare il rispetto della normativa. La responsabilità vera è in capo agli organi locali e soprattutto alla Regione Calabria, che è obbligata per legge – ex D. Lgs. 152/2006 – a stilare l’anagrafe dei siti da bonificare. Nonostante tale obbligo, tale anagrafe ancora non esiste. Perché? Per trovare risposta occorre addentrarsi nei meandri della burocrazia. Innanzitutto, l’anagrafe dei siti da bonificare è parte di un documento più ampio, il «piano bonifiche», che a sua volta è parte di un documento ancora più ampio, conosciuto come «piano rifiuti». Senza aggiornamento del «piano rifiuti», non ci sarà nessun nuovo «piano bonifiche».
Come si sa, l’atteso nuovo Piano Rifiuti è fermo alla Regione, bloccato anche per le criticità fatte rilevare in modo puntuale dalle associazione ambientaliste. Quello attuale in vigore risale al 2007, ma poiché all’epoca la Regione Calabria era in regime commissariale, si decise di recepire una precedente lista dei siti inquinati risalente al 2002, la quale – a sua volta – recepiva in toto la lista stilata nel 1999. Come dire, mentre il bubbone Legnochimica era già esploso, a livello regionale si ragionava su una fotografia della situazione risalente ad almeno 8 anni prima (oggi ne sono trascorsi addirittura 17). Da questa fotografia, la Legnochimica è tutt’ora assente.
A complicare ulteriormente la vicenda c’è stato certamente lo scarso zelo del Comune di Rende, che – a quanto pare – non ha mai trasmesso agli uffici regionali alcuna formale richiesta di inserimento del sito della Legnochimica nell’anagrafe regionale.
Mancherebbe cioè da sempre una qualsivoglia istruttoria della pratica, che secondo prassi deve essere effettuata a cura dell’interessato. Questa situazione è in evidente contrasto con la mobilitazione spontanea di cittadini e comitati che da anni chiedono giustizia. Attraverso l’appassionato impegno di tanti cittadini è stato possibile dimostrare nel tempo che buona parte delle difficoltà tecniche o amministrative che finora hanno bloccato la bonifica sono in realtà superabili.
A titolo di esempio, non è vero che occorrano molti milioni di Euro per bonificare il sito; non è vero che la bonifica pubblica non possa riguardare siti privati (vedi “Terra dei Fuochi”); non è neppure vero che la bonifica debba per forza di cose essere effettuata fuori-sito (leggi, mandare i rifiuti in discariche speciali). E’ sufficiente apprendere da casi simili in giro per l’Italia.
Ad oggi l’unica proposta seria per tenere bassi i costi di bonifica da metalli pesanti è l’utilizzo di tecniche integrate di fitorimedio, per come già tentato con successo in altre aree d’Italia (Crotone, Taranto, Terni, Porto Marghera). Tale scelta è ambientalmente ed economicamente sostenibile, perfino più conveniente di una semplice messa in sicurezza. Ad onor del vero occorre dire che la bonifica dei suoli è solo parte di un discorso più ampio di protezione dalle fonti di inquinamento.
Infatti, poiché esistono seri dubbi sullo stato di salute delle falde sotterranee che finiscono nel Fiume Crati, non avrebbe senso bonificare i suoli se gli acquiferi sotterranei fossero contaminati. Avrebbe invece senso il contrario, cioè intervenire sugli acquiferi sotterranei per abbatterne l’inquinamento, in attesa di un più sostanziale intervento di bonifica sui suoli.
Ciò è coerente con quanto prevedono numerose Direttive Comunitarie, tra cui la 2006/118/CE e la 2014/80/UE “sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”, nonché i relativi decreti di attuazione, ovvero il D. Lgs n. 30 del 16 marzo 2009 e il D. L. n. 91 del 24/06/2014. In particolare, le direttive comunitarie prevedono l’obbligo di mappare e di valutare periodicamente lo stato chimico delle acque, nonché obbligano le autorità competenti a trasmettere informazioni rilevanti per ridurre l’eventuale inquinamento presente nelle acque sotterranee. Nonostante tale obbligo però, l’intero Mezzogiorno risulta attualmente assente da numerose statistiche dell’Agenzia Europea per l’Ambiente.
Pertanto, gli attuali strumenti di legge potrebbero rivelarsi assai utili. Perfino le sentenze del Tar Calabria, che hanno rigettato in più occasioni i provvedimenti di urgenza del Comune di Rende, forniscono indicazioni utili su come impostare efficacemente un’istruttoria su problematiche ambientali. Se solo lo si vuole.
Questi strumenti potrebbero addirittura consentire di semplificare la tradizionale procedura di bonifica, senza necessità di espropriare terreni, minacciare sanzioni o perfino senza ulteriori ricorsi amministrativi, bensì attraverso misure di studio e di prevenzione, tra cui l’istituzione di presidi permanenti di monitoraggio e di valutazione della qualità delle acque.
Purtroppo sia le Direttiva sia i decreti rimangono inapplicati nella nostra regione, che sconta un ritardo storico per quanto riguarda il recepimento della normativa comunitaria. Nel frattempo, tutti i rapporti ufficiali sullo stato di salute del Crati ci dicono che le sue acque sono sensibilmente deteriorate nel corso degli anni, proprio nel tratto che interessa l’area urbana e che arriva fino alla Riserva Naturale del Lago di Tarsia, tanto che il Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria le definisce in più punti addirittura «non idonee alla vita dei pesci».
La vicenda della Legnochimica di Rende può e deve arrivare ad una conclusione. Lo dobbiamo a noi stessi, ma soprattutto lo dobbiamo fare considerando le relazioni esistenti tra ecosistemi naturali e catena alimentare.