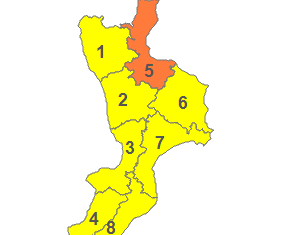La festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale istituita per ricordare la nascita della Repubblica in quel lontano 2 giugno 1946. Dopo la caduta del fascismo, al termine di una sanguinosa guerra civile e della seconda guerra mondiale, con un referendum istituzionale non privo di polemiche e ombre, che sancì la fine della monarchia, si assiste alla nascita della Repubblica e alla sua carta costituzionale.
Si trattò di un passaggio di grande importanza per la storia d’Italia dopo il ventennio fascista e la tragicità della guerra, rappresentando un periodo di riscatto, di vera rinascita morale e economica. Oggi tale ricorrenza, celebrativa anche di unità nazionale, si presenta in un momento di grave sofferenza per il Paese, legato agli effetti economici post pandemia, e ad un rigurgito di esasperante regionalismo che condiziona fortemente lo spirito unitario dello Stato.
Così nel corso della pandemia da coronavirus, le decisioni, le contraddizioni e le scelte sanitarie espresse da alcuni governatori in contrapposizione alle direttive nazionali hanno messo in luce una dissonanza tra gli organi di governo nazionale e quelli periferici. In alcuni territori le scelte scellerate, ora al vaglio della magistratura, e le pressioni del mondo economico imprenditoriale hanno influito notevolmente sull’esito negativo della pandemia con migliaia di decessi e innumerevoli contagi.
Ecco allora in una vorticosa girandola di ordinanze, decreti, e provvedimenti spesso contraddittori, riaffiorare l’Italia dei comuni, dei mille campanili, e delle regioni che ergendosi a monadi cercano in tutti i modi di condizionare e spesso ostacolare l’operato del governo centrale, cercando poi, di fronte a responsabilità evidenti, di scaricare ipocritamente le proprie colpevolezze sul governo nazionale. Una triste sceneggiata della politica dei nostri giorni, che proprio in questa ricorrenza ci deve far riflettere.
Quanto al resto, c’è appena da ricordare che, in merito a questa benedetta o maledetta unità nazionale, non è sempre come la raccontano i testi scolastici di storia. Non lo è per esempio quando la storia parla il linguaggio dell’Unità e dell’Unificazione. Non quando tratta i fatti del 1860. Non quando semina la convinzione che il sottosviluppo del Sud fosse presente già prima dell’Unificazione e non dice invece che il sottosviluppo parte proprio dal 1860, soprattutto a causa dell’Unificazione, realizzata con metodi non democratici, violenti, teste mozzate, e soprattutto con un grave danno economico dovuto all’unificazione monetaria tutta a vantaggio del Nord ma a svantaggio del Sud. Il quale all’epoca deteneva monete in gran quantità e con un valore superiore quattro volte quello della moneta piemontese.
Per non parlare del debito pubblico, di entità trascurabile fino a quel momento al Sud, e pesantissimo al Nord. E non si parli neppure di arretratezza culturale o scientifica, poiché l’elenco di primati spettanti al Sud sono davvero tanti, sebbene non vengano ricordati con la dovuta attenzione.
Una storia che va riscritta, senza omissioni ma anche senza retorica, per colmare quei vuoti della memoria responsabili delle grandi lacerazioni oggi presenti nel tessuto sociale di questo Paese. Una storia che riconosca il grande contributo, soprattutto economico dato dal Sud non solo all’epoca dell’Unità, ma anche successivamente e nei momenti cruciali della crescita economica del Paese. La storia è pensiero critico, è analisi di cause ed effetti, ed in questa ottica vanno affrontate alcune vicende della nostra storia che, seppur lontane nel tempo, allungano i tentacoli delle loro conseguenze fino ai nostri giorni.
A partire da quel pregiudizio antimeridionale, alimentato all’epoca dell’Unità dal pensiero positivista, che ha avuto derive razziste prese a modello anche in altri momenti della storia. Anche il fenomeno del brigantaggio non può più essere liquidato come un fatto delinquenziale tout court: il ribellismo contadino è un effetto di cui vanno ricercate e capite le cause, anche per restituire dignità a quei contadini che, comunque sono morti per un ideale e sono morti da italiani.
Ed è nell’ottica causa-effetto che va letto ed affrontato il grave problema dell’attuale divario economico Nord-Sud, un problema nato all’interno della storia unitaria, come ampiamente dimostrato da autorevoli studi economici e come già documentato dagli studi di Francesco Saverio Nitti confermati da Luigi Einaudi. La soluzione del problema del divario è la chiave per far tornare a crescere l’Italia, oltre ogni pregiudizio e oltre la retorica.
L’unità era necessaria. Il fatto è che bisognava fare un’unione politica, ma rispettando le diversità e le diverse economie, e riconoscendo poi il contributo che ciascuno diede all’Unità. Alla luce dei fatti, che sono inconfutabili, è ormai riconosciuto da storici non certo meridionalisti che in effetti il modo in cui fu fatta l’Unità, essa stessa rappresentò per l’economia meridionale il tracollo economico. Che prese avvio al momento dell’Unità e che non è stato ancora risolto. Proprio l’Unità ha inaugurato quel meccanismo di sviluppo ineguale per cui al Nord s’avviò il processo di sviluppo industriale. Il triangolo industriale ebbe inizio alla fine dell’Ottocento, la Fiat stessa nacque nel 1899, mentre il Sud rimane ancora oggi il mercato di consumo del Nord. Il classico meccanismo che si instaura tra sviluppo e sottosviluppo. Sono due facce della stessa medaglia.