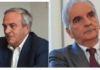Capitolo 4
Ponte sullo Stretto di Messina: ancora non viene spiegato a cosa serve per la mobilità e i trasporti locali e nazionali
di Anna Donati, coordinatrice Mobilità Sostenibile Kyoto Club
Il rilancio in grande stile da parte del Ministro Salvini e del Governo Meloni a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, a partire dal Documento di Programmazione Economica 2023 e Allegato Infrastrutture, non spiegano mai le motivazioni e l’utilità dell’opera.
Non vi sono dati aggiornati sulla mobilità ed il traffico e sulla strategia complessiva che si vuole perseguire realizzando la “grande opera” infrastrutturale. Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2023 si scrive di “opera non più rinviabile e considerata di assoluta strategicità da questo Governo per l’Italia e per l’Europa nel suo complesso, in coerenza con il disegno dei Corridoi delle reti transeuropee di trasporto TENT, i quali prevedono l’obiettivo strategico del collegamento tra Palermo e Berlino, nonché, finalizzato a dare maggiore efficacia alla realizzazione della ferrovia ad alta velocità da Salerno a Reggio Calabria e alla velocizzazione delle ferrovie siciliane.” Nel testo inoltre si richiamano generici obiettivi ambientali con significativa riduzione della CO2, ma non si inseriscono ulteriori specifiche e spiegazioni di come saranno raggiunti questi obiettivi.
Il Decreto Legge 35/23 rimanda al futuro l’aggiornamento dello Studio di Traffico. Del resto il DL 35/2023 in corso di conversione da parte del Parlamento, che ripristina la Società Stretto di Messina Spa, resuscita il vecchio progetto di ponte sospeso e restituisce il contratto dopo 10 anni di cancellazione alle imprese (come se niente fosse), niente dice sull’adeguamento del progetto in termini di mobilità e trasporti.
L’unico riferimento è all’articolo 2, comma 8, punto c) quanto richiede di aggiornare il Piano Economico e Finanziario della Concessione, con la previsione dei “ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l’attraversamento del collegamento stabile, ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell’opera stradale e ferroviario”.
Ed al punto successivo prevede “il canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla società concessionaria, riscosso dalla società R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell’opera e trasferito alla società concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti dalla società R.F.I. S.p.a.” Quindi si torna alla vecchia e sbagliata idea che l’equilibrio economico del Ponte lo dovrà pagare RFI, con una vera e propria “tassa” sul trasporto ferroviario.
Ovviamente avremo poi modo di vedere in futuro la nuova Concessione ed il Piano Economico e Finanziario allegato, con l’aggiornamento del Piano del Traffico e con ricavi, pedaggi, canoni e costi di gestione, che avremo modo di valutare. Ma resta una grave carenza quella di non aver aggiornato i dati e la strategia di mobilità del 2023, su cui si fondano le ragioni per cui viene invocata la realizzazione e l’utilità del Ponte sullo Stretto, di tutto l’iter di riavvio del progetto.
Per il momento, dunque, non possiamo che riferirci sugli aspetti trasportistici più aggiornati e disponibili, che sono quelli inclusi nella Relazione del Gruppo di Lavoro incaricato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di studiare “La valutazione di soluzioni alternative per il sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina” presentata il 30 aprile 2021, per fare alcune valutazioni sull’utilità trasportistica del Ponte.
Il ponte aiuta gli spostamenti tra le città dello Stretto?
Una delle tesi presentate a supporto della costruzione dell’opera è la riduzione dei tempi di spostamento nella cosiddetta “città dello Stretto”. Nello studio si legge che il 76,2% degli spostamenti su nave in ambito locale avviene da parte di passeggeri senza auto al seguito, e complessivamente coloro che ogni giorno si muovono tra le due sponde sono 4.500 persone, un numero assai esiguo a confronto con altre direttrici nazionali. Per questi spostamenti oggi esiste un’offerta articolata con cinque compagnie che operano con servizio passeggeri e auto al seguito o treno, lungo le direttrici Messina-Reggio Calabria per le persone con la possibilità di auto al seguito, sulla rotta Messina-Villa San Giovanni per persone, auto e camion, treni, sulla Tremestieri verso sia Villa San Giovanni che Messina per camion e auto, con tempi medi di percorrenza di 20-30 minuti. I due collegamenti principali sono Messina-Villa San Giovanni come numero di passeggeri, considerando anche quelli di lunga distanza, e Tremestieri-Villa San Giovanni per le merci. L’offerta tra Messina e Villa S. Giovanni è di 182 corse al giorno, se si sommano quelle previste dalle due compagnie, Caronte&Tourist e Blu Jet.
Nel primo caso i collegamenti avvengono ogni 40 minuti mentre nel secondo ogni ora. In entrambi i casi i tempi di percorrenza sono tra i 20 e i 35 minuti.
Nessuna soluzione infrastrutturale potrà essere competitiva rispetto a tempi ed offerta di questo tipo, considerando il percorso necessario in autobus o auto privata per raggiungere il ponte e di ingresso e uscita dalla città. Piuttosto è interessante quanto scritto nel documento in Relazione ai punti critici di questi spostamenti, dovuti alla bassa qualità dei terminali passeggeri, alla bassa accessibilità alle stazioni dei treni, vetustà del naviglio (lungo queste distanze stanno diventando sempre più competitive navi a propulsione elettrica), scarsa organizzazione delle coincidenze con il trasporto pubblico locale, ma anche di percorsi pedonali e ciclabili. Tutti interventi urgenti, rinviati perché assurdamente considerati alternativi al ponte, realizzabili in tempi brevi e che potrebbero rendere più attraente per i turisti quest’area della Sicilia e aiutare studenti e pendolari.
Al contrario con pochi investimenti ma coordinati si potrebbe, in poco tempo, arrivare ad un sistema integrato che metta nelle condizioni di potersi muovere in treno e in traghetto tra le città che si affacciano sul mare in pochissimo tempo. Ad esempio riorganizzando gli orari dei traghetti sia a Messina sia a Villa San Giovanni in modo da garantire un’attesa minima per i treni. Inoltre, lo spostamento dei traghetti FS Bluferries dal porto storico di Messina a quello di Tremestieri, avvenuto nell’autunno 2014, è stata positiva per le merci ma ha penalizzato lo spostamento di migliaia di pendolari sulle due sponde.
Il ponte aiuta a rendere più veloce e sostenibile il trasporto delle merci?
Anche questo obiettivo non viene raggiunto, sulla base dei dati attuali, dalla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Basta valutare l’analisi dei flussi merci tra la Sicilia e la Penisola che indica che “nel 2019 sono stati trasportati 624.246 mezzi pesanti, in prevalenza verso la Campania (276.290) e la Liguria (173.682). Quindi i collegamenti con i porti della Campania costituiscono una quota rilevante (44%) del totale e quindi un collegamento stabile attraverso lo Stretto ben difficilmente potrebbe servire a questo segmento di traffico, come è stato invece ipotizzato, pur di riempire il Ponte.
Viene da chiedersi perché mai si debba puntare a ridurre il trasporto di merci che viaggiano via nave per spostarli verso la strada (con evidente aumento di traffico, inquinamento ed emissioni di gas serra) ma anche in treno. Per quanto riguarda il trasporto merci su ferro ha senso dalla Sicilia potenziare i collegamenti verso Calabria, Puglia, Basilicata (oggi purtroppo assai difficili), perché per le altre regioni e verso Nord il trasporto via mare permette di muovere maggiori quantità di merci. Poco senso avrebbe utilizzare i porti siciliani come nodi di trasbordo dalle navi ai treni, per trasporto verso nord, visti i vantaggi di porti come Gioia Tauro o Taranto.
Davvero difficile, inoltre, che la realizzazione del Ponte riesca ad essere attrattivo rispetto al traffico merci che oggi avviene in aereo, limitato come quantità (6mila tonnellate nel 2019) ma specializzato su alcuni segmenti tecnici e alimentari che richiedono tempi e condizioni particolari.
Il ponte sarebbe competitivo per gli spostamenti nazionali di persone?
Negli ultimi dieci anni è cresciuto fortemente il numero di spostamenti in aereo verso la Sicilia, in particolare per la crescita dell’offerta low cost, e nel 2019 copriva il 60,3% di quelli di lunga percorrenza. Segue nel numero di spostamenti nazionali quello su strada con il 19,2% e poi il trasporto ferroviario (10,3%) e navale (10,2%). Circa il 60% degli spostamenti in aereo avviene verso aeroporti al Nord, rispetto ai quali la realizzazione del Ponte difficilmente potrebbe risultare competitivo come alternativa di spostamento in treno, se non tramite convogli notturni.
E’ la stessa Relazione MOMS del 2021 ad ammettere che “Tra le destinazioni solo Napoli e Roma appaiono contendibili da un efficiente servizio ferroviario: nell’insieme, questi due aeroporti muovono 3,9 milioni di passeggeri; si deve tuttavia, che una parte di essi scelgono questi aeroporti, soprattutto Roma Fiumicino, come scalo intermedio per raggiungere altre destinazioni e non sarebbero di conseguenza attratti da un servizio ferroviario”.
L’obiettivo che occorre porsi è di capire come facilitare gli spostamenti dalla Sicilia verso il resto d’Italia rendendoli anche più sostenibili. La riduzione di 35-55 minuti di attraversamento del ponte non potrà in ogni caso rendere competitivo lo spostamento in treno con quello in aereo, su direttrici come da Palermo verso Roma (oggi il treno più veloce ci mette 10 ore e 25 minuti) e da Catania verso Roma (il più veloce ci mette 9 ore e sette minuti).
Oggi l’offerta di treni a lunga percorrenza rimane esigua, con due soli Intercity al giorno sia da Palermo sia da Catania, malgrado gli interventi realizzati di upgrade tecnologico sulla linea. I tempi di percorrenza tra Messina e Villa S.Giovanni sono di 1 ora e 10 minuti in tutto. E’ sicuramente importante ridurre i tempi dei treni diurni e di quelli notturni verso Nord, ma è evidente che si andrà ad incidere su una quota limitata dei flussi e che esistono soluzioni con maggiori risultati in termini di costi e benefici.
Il PNRR finanzia con circa 10 miliardi di euro la realizzazione della tratta Salerno-Praia a Mare la cui conclusione è prevista nel 2030. A questo proposito bisogna ricordare come la linea ferroviaria SA-RC, sia già oggi interamente a doppio binario, grazie agli interventi fatti in questi anni, e presenti caratteristiche moderne che consentono velocità sino a 200 km/h: Roma è raggiungibile da Reggio Calabria in circa 4 ore e mezza, e con ulteriori interventi puntuali, di costo ed impatto ridotto, si potrebbe scendere al di sotto delle 4 ore.
Bisognerebbe prendere in considerazione una soluzione dai costi contenuti che renderebbe possibile dare continuità al percorso dei treni veloci, con soluzioni realizzabili in pochi anni. Attualmente per entrare nelle navi le carrozze dei treni vengono separate con manovre complicate, inoltre le navi, avendo un solo ingresso dei treni, portano a manovre in porto che fanno perdere ulteriore tempo, tanto che si arriva a tempi di circa due ore. Eppure, si potrebbe migliorare questa situazione attraverso traghetti Ro-Ro lunghi 200 metri, come si trovano nel Mar Baltico. In questo modo le frecce di Trenitalia o gli Italo fino a sette carrozze potrebbero entrare senza essere smontati direttamente nella nave e direttamente uscire nel porto di sbarco, grazie a un sistema di doppia entrata dei traghetti. Una soluzione di questo tipo permetterebbe di dimezzare i tempi di attraversamento dei treni lungo lo stretto, scendendo a circa 40 minuti.
Il Ponte è davvero quello che serve per il rilancio del Sud?
Con grande enfasi il documento propone il ponte sullo stretto come l’opera che può consentire alla Sicilia e al Sud di uscire dalla attuale marginalità geografica, dalla curva demografica e dalla crisi economica e sociale.
A supporto di queste tesi vengono portati i risultati di crescita del PIL realizzati nelle aree collegate all’alta velocità ferroviaria e la possibilità di connettersi ai nuovi flussi internazionali delle merci e del turismo nell’epoca della globalizzazione. Il problema è che l’analisi non va oltre i titoli e non potrebbe essere altrimenti, perché le situazioni non sono confrontabili in termini geografici ed economici, e nessun economista serio potrebbe partire da queste basi per motivare la scelta di costruire l’opera.
Il Ponte rimane uno slogan politico che consente di nascondere il fallimento delle politiche di questi anni per il Sud e l’assenza di una strategia per il futuro. L’unica novità è rappresentata dal PNRR che permetterà di investire nel Mezzogiorno per recuperare una parte del deficit di risorse per il diritto allo studio e per ridurre la piaga dell’abbandono scolastico, per gli asili nido, il patrimonio edilizio pubblico, la sanità. Veniamo da anni di risultati fallimentari del complesso di politiche per il Sud costruite intorno ai fondi strutturali gestiti dalle Regioni e attraverso i Piani operativi nazionali.
Mai si è aperta una riflessione su cosa si è finanziato in questi decenni e quali risultati abbia prodotto. Nessuno sa quali politiche hanno funzionato o quali problemi siano stati affrontati e magari in parte risolti, quante siano state le scuole riqualificate, le classi e i ragazzi recuperati dal rischio abbandono scolastico, le imprese capaci di rilanciarsi attraverso le risorse di cui hanno beneficiato. In un’area del Paese che si è andata negli ultimi decenni spopolando, con oltre 600mila giovani che sono emigrati dal 2012, come può il collegamento tra Reggio Calabria e Messina rappresentare la risposta ai problemi? Il Sud ha bisogno di nuove infrastrutture che siano funzionali a un’idea di sviluppo calata dentro gli obiettivi di Next Generation UE, in modo da orientare in questa direzione anche la prossima programmazione 2021-2027, avendo imparato dagli errori del passato e assunto nelle Regioni le nuove priorità europee a partire da quella climatica.
Ma oggi più che di grandi opere abbiamo bisogno di una visione che accompagni le scelte di decarbonizzazione in questa area del Paese e crei così opportunità per i cittadini e le imprese. Le Regioni del Sud godono di risorse straordinarie per sviluppare un diffuso sistema di impianti da fonti rinnovabili, per organizzare una articolata filiera di recupero e riciclo, e di sicuro ha tutto da guadagnare puntando su qualità dell’offerta,
innovazione e sostenibilità ambientale nelle città e nei territori. Il Sud Italia in questa prospettiva ha delle carte da giocare importanti, per le risorse di cui dispone e perché attraverso queste chiavi può dare risposta ai propri problemi (ad esempio l’eterno problema discariche dei rifiuti) e creare opportunità per le imprese dall’autoproduzione da fonti rinnovabili, può far tornare attrattive le proprio città attraverso la chiave della vivibilità e aumentare l’attrattività turistica intorno alla possibilità di rendere finalmente accessibile un patrimonio unico per articolazione e ricchezza.
Ma per fare questo salto in avanti ha bisogno di un piano per la mobilità al Sud che mai il MIT ha studiato e che ancora ora non è previsto. Un piano che, come avviene negli altri Paesi europei, vada a verificare come funziona il servizio (pagato da risorse pubbliche) e se le coincidenze tra treni nazionali e regionali permette di garantire tempi di spostamento competitivi lungo le direttrici principali in modo da rendere accessibili le città, i porti e gli aeroporti. Per il turismo un servizio con queste caratteristiche renderebbe finalmente attraente il Mezzogiorno per una fetta crescente del turismo internazionale che ama viaggiare senza dover disporre di un’auto privata. In questi anni al Sud il numero di treni si è ridotto, con meno Intercity e treni regionali.
Quello che è normale al Nord qui è impossibile, ossia muoversi tra Bari e Napoli, tra Reggio Calabria e Taranto, tra Potenza e Lecce, perché può portare a viaggi di ore e a dover scontare numerosi cambi obbligati anche solo per poche decine di chilometri di tragitto, mentre le coincidenze e i collegamenti intermodali rimangono un sogno. E’ evidente che questa situazione determina gravi conseguenze nei confronti dell’economia e del turismo. Se non si affrontano questi problemi, che sono di servizio ancora prima che infrastrutturali, il Ponte sullo Stretto continuerà a risultare una proposta demagogica per il riscatto di territori di cui si rinuncia a capire i problemi, cresciuti in questi anni, ma anche le potenzialità.