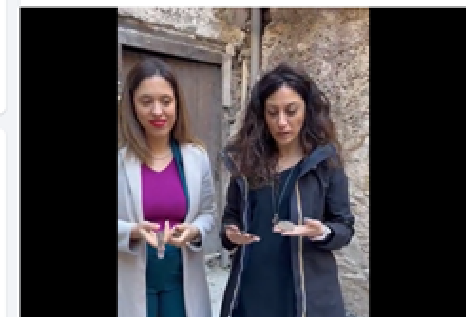La farsa dei reperti e la complicità di molti: il potere corrotto che si nutre del silenzio
Dove si trova la vera forza dell’amministrazione Succurro? Non certo nella trasparenza o nella buona gestione, ma nella rete di complicità e servilismo di chi, pur di ottenere vantaggi personali, si piega a ogni tipo di compromesso. Tecnici, ingegneri, geometri, architetti e persino archeologi: tutti sembrano pronti a svendere la propria dignità in cambio di qualche spicciolo pubblico. È una corruzione silenziosa, fatta di piccoli favori, compensi immeritati e bugie ben confezionate, che permette a questa classe politica di continuare a governare indisturbata.
Un esempio lampante è il caso dei presunti reperti archeologici nei cunicoli badiali. È passato un anno, e ancora non si sa nulla di concreto. Dove sono finiti quei “ritrovamenti inestimabili” di cui tanto si parlava? Nel frattempo, l’archeologa incaricata, moglie di un politico locale noto per cambiare bandiera a seconda della convenienza, ha intascato ben duemila euro per un sopralluogo privo di risultati. Una somma elargita non per il merito, ma per mantenere saldo il sistema clientelare che alimenta questa amministrazione.
È così che si regge il potere: grazie a una lunga catena di servi e opportunisti pronti a tutto pur di guadagnare qualcosa. La corruzione non è fatta solo di grandi scandali, ma anche di queste piccole complicità quotidiane, di sorrisi falsi e inchini che perpetuano un sistema marcio fino al midollo. E mentre questi giochi di potere continuano, i cittadini pagano il prezzo più alto.
La vicenda dell’archeologa è emblematica. L’anno scorso proclamava con enfasi la scoperta di reperti “inestimabili”, con il benestare della sindaca che non lascia spazio ad altri di parlare o di agire. Una sindaca che si erge a unica voce, mentre intorno a lei tutto tace o applaude in silenzio. Perché? Perché chi osa opporsi rischia di essere escluso dai favori del sistema.
Questa amministrazione si regge proprio su questo: la paura di perdere un tornaconto, un compenso o un privilegio. Tutti si prostrano, tutti si adeguano, alimentando un circolo vizioso che distrugge la fiducia nelle istituzioni. La sceneggiata dei reperti, costata alle casse comunali oltre duemila euro, è solo uno degli esempi più evidenti di come il denaro pubblico venga sprecato per sostenere un teatrino fatto di finti ritrovamenti e bugie ben orchestrate.
Ma questa non è solo una questione di spreco economico. È una questione morale. Finché ci saranno persone disposte a piegarsi al potere, finché ci sarà chi accetta di prostituirsi intellettualmente per una mancetta, questo sistema continuerà a prosperare. E con esso continueranno a prosperare politici mediocri, incapaci di amministrare ma abilissimi nel manipolare. La corruzione non è solo in chi governa, ma in chi permette loro di farlo, giorno dopo giorno, senza opporsi.
La corruzione non è solo in chi governa, ma in chi permette loro di farlo, giorno dopo giorno, senza opporsi. È un sistema alimentato dalla connivenza di chi preferisce piegarsi piuttosto che alzare la testa, di chi trova più comodo accettare il compromesso piuttosto che combattere per un cambiamento. È qui che si insinua la vera radice del problema: non nella figura del singolo politico corrotto, ma nella rete di connivenze che lo circonda, lo protegge e gli consente di continuare a governare indisturbato.
Questa complicità è spesso nascosta dietro la maschera del silenzio. Nessuno parla, nessuno denuncia, nessuno si oppone apertamente, perché farlo significherebbe rischiare. Rischiare di perdere un posto, un incarico, un’opportunità di guadagno. Ma questa omertà, questa accettazione passiva, non è altro che un’ulteriore forma di corruzione. È la corruzione di chi sceglie di voltarsi dall’altra parte, di chi accetta lo stato delle cose come inevitabile, di chi si convince che opporsi sia inutile o addirittura dannoso per i propri interessi.
È così che si crea una spirale perversa: il potere corrotto si rafforza grazie alla debolezza morale di chi lo circonda. Gli amministratori incapaci e opportunisti trovano terreno fertile in una comunità che, anziché indignarsi, si abitua all’ingiustizia. E non si tratta solo di coloro che traggono un vantaggio diretto dal sistema, ma anche di chi, pur non beneficiandone, sceglie di restare in disparte, di non disturbare, di non fare domande.
Il caso dell’archeologa è emblematico. Moglie di un politico che ha fatto del trasformismo la sua strategia, non solo ha intascato denaro pubblico per un lavoro dai risultati dubbi, ma ha anche rafforzato quel sistema di silenzi e omertà che consente a queste dinamiche di perpetuarsi. Annunciava con enfasi il ritrovamento di reperti “inestimabili”, ma senza mai fornire prove concrete. E intanto, chi avrebbe dovuto vigilare, chi avrebbe dovuto chiedere trasparenza, ha preferito tacere. Perché? Per paura? Per interesse? Per abitudine?
Questo atteggiamento è forse la forma più subdola di corruzione. È una corruzione che non si misura in tangenti o mazzette, ma in una rinuncia alla responsabilità civile. È la corruzione di chi non fa domande, di chi non chiede rendiconti, di chi accetta di essere governato da incompetenti pur di non rischiare di perdere il poco che ha.
Ed è proprio questa corruzione diffusa che permette al sistema di perpetuarsi. Ogni volta che qualcuno sceglie di non denunciare, ogni volta che qualcuno preferisce il silenzio alla verità, contribuisce a rafforzare il potere di chi governa senza scrupoli. E così, il sistema cresce, si consolida, si radica sempre più profondamente. Diventa parte della normalità. Diventa un modo di vivere.
Ma a quale costo? Il costo non è solo economico, anche se gli sprechi di denaro pubblico sono evidenti e documentati, come nel caso dei duemila euro spesi per una sceneggiata priva di sostanza. Il costo è soprattutto morale. È il prezzo che paghiamo in termini di perdita di fiducia, di speranza, di dignità. È il prezzo di una società che si abitua al degrado, che accetta l’ingiustizia come parte del quotidiano, che smette di credere nella possibilità di un cambiamento.
Finché la corruzione sarà percepita come inevitabile, finché continueremo a pensare che “tanto non cambia nulla”, questo sistema non farà altro che rafforzarsi. Ed è proprio su questa rassegnazione che i politici mediocri e corrotti fanno affidamento. Non temono la critica, non temono l’opposizione, perché sanno che il vero nemico è l’indifferenza.
E allora, la domanda che dobbiamo porci è: vogliamo davvero continuare così? Vogliamo davvero accettare che il nostro futuro sia deciso da chi agisce solo per il proprio tornaconto? Vogliamo davvero lasciare che la corruzione diventi la norma, il punto di riferimento su cui costruire la nostra società?
La risposta a queste domande non può venire dall’alto. Non possiamo aspettarci che siano i politici a cambiare il sistema, perché il sistema è ciò che li sostiene. La risposta deve venire da noi. Da chi ha il coraggio di alzare la testa, di fare domande, di chiedere trasparenza, di denunciare ciò che non funziona.
Perché la corruzione non è solo in chi governa. È in ognuno di noi, ogni volta che scegliamo il silenzio al posto della verità, ogni volta che accettiamo il compromesso al posto della giustizia, ogni volta che decidiamo di non opporci. Il cambiamento inizia da qui.