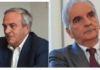di Mariafrancesca D’Agostino
Per la questura di Cosenza, Simone Guglielmelli e Jessica Cosenza costituiscono un pericolo per la società, e si utilizza di conseguenza l’arma della sorveglianza speciale per sottoporli a un regime di controllo che potrebbe avere ricadute devastanti sulla loro vita e le loro future carriere. Dai riscontri avuti fin qui non capiamo tuttavia quali siano i reati contestati. D’altra parte, non nutro alcun dubbio sul talento, la lealtà, la correttezza di Jessica e Simone. Il mio lavoro mi ha portato a incontrarli di continuo: a intervistarli, a invitarli a tenere delle lezioni nei miei corsi all’Università, a coinvolgerli nella Summer school organizzata la scorsa estate a Cosenza vecchia sul “diritto alla città”.
Per chi si occupa di migrazioni, partecipazione politica e cittadinanza attiva era imprescindibile questo confronto. Da diversi anni, ormai, noi sociologi andiamo alla disperata ricerca di tracce di innovazione sociale che possano aiutare a ripensare in chiave più sostenibile i processi di sviluppo economico-sociale che attraversano la società. È stato facile trovare un esempio di questa politica nuova nelle forme di abitare interculturale che Jessica e Simone hanno contribuito a inventare. Innovazioni che, in particolare, hanno portato avanti attraverso il recupero di alcuni stabili ormai abbandonati e dismessi, mettendo a nudo tutte le contraddizioni insite negli attuali modelli emergenziali di accoglienza: modelli ghettizzanti ed economicamente insostenibili, che fingono di non vedere l’immenso patrimonio immobiliare dismesso presente in Calabria e nell’intero Paese.
Ed ancora, non potevo non prendere sul serio i nuovi modelli di “welfare comunitario” che Jessica e Simone, insieme a Francesco Azzinnaro (anche lui sottoposto alla stessa misura di sorveglianza speciale) hanno proposto e faticosamente messo in piedi, posizionandosi nel centro storico di Cosenza. Attorno a questo tema, Simone ha sviluppato con me la sua tesi di laurea, aprendo un confronto serrato con la copiosa letteratura sulla materia. Letteratura che per l’appunto si concentra sull’emergere di nuove modalità di partecipazione e conflitto che, anche quando connotate da momenti radicali di protesta, affermano diritti altrimenti negati riunendo le fasce più deboli della popolazione al di sotto di originali patti di mutuo-soccorso.
Non sono la sola, del resto, a poter testimoniare la validità e i tanti traguardi raggiunti da queste lotte, la loro capacità di curare il territorio e la qualità democratica delle nostre istituzioni. Ricordo un’intervista con il sindaco di Cosenza durante la quale egli stesso mi rappresentò i percorsi di apprendimento istituzionale sollecitati dai comitati cittadini entro cui si colloca l’agire di Simone, Jessica e Francesco. Anche per Mario Occhiuto, proprio grazie alle loro sollecitazioni, l’amministrazione cittadina decise di istituire la “via dell’accoglienza” a Cosenza. Una via fittizia che, in ottemperanza a quanto previsto dal nostro ordinamento, finalmente consente a chi è senza fissa dimora di poter accedere ai servizi locali del welfare. Ma anche a livello regionale sono in tanti a riconoscere che la legge sull’auto-recupero del patrimonio immobiliare pubblico varata dalla Giunta Oliverio si stata sostanzialmente scritta dal movimento cosentino.
L’eco di questi avanzamenti, in una società sempre più inquieta e sfiduciata, ha inevitabilmente scavalcato i confini calabresi, richiamando l’interesse di giornalisti, studiosi e finanche di registi premiati a Venezia. Resoconti dettagliati sulle pratiche di solidarietà di cui si sono resi protagonisti Jessica, Francesco e Simone si ritrovano facilmente sulle pagine del Venerdì di Repubblica, ma anche su libri e riviste scientifiche.
Su questi stessi aspetti si sofferma poi un documentario molto bello: “Dove bisogna stare”. L’ho presentato con Jessica ai miei studenti dell’Unical convinta che la deprivazione culturale, l’alienazione, l’assenza di filtri critici siano i veri mali della nostra società. Gli ingredienti con i quali sono impastati gli autoritarismi e i fascismi di ogni tempo, anche quelli più nuovi. “Dove bisogna stare” indica una possibile risposta a questi rischi e ai nostri tempi cupi. Come dimostra la vicenda di Mimmo Lucano, non è certo facile collocarsi dalla parte dei migranti e dei più deboli in uno scenario politico che criminalizza la solidarietà e individualizza le responsabilità per rendere la povertà moralmente accettabile. Ma, fortunatamente, esistono uomini e donne che non si rassegnano allo status quo. Che non smettono di sognare, che non rinunciano a costruire una società migliore. Sono i più autentici anticorpi che abbiamo per contrastare le derive illiberali che si affacciano all’orizzonte. Arrestare questi sforzi significa rendere tutti noi più deboli. Per quanto possa rimanere senza ascolto, alla questura mando questo messaggio e una richiesta accorata: ritirate i vostri ingiusti provvedimenti