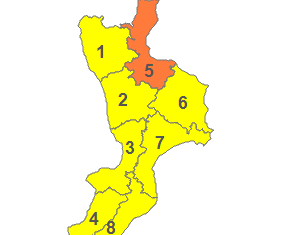di Maurizio Crosetti
Fonte: Repubblica
Pelè era il nome di un sogno, il nome di dio. Aveva una voce profonda e cavernosa da contrabbasso, e quel suono usciva da un corpo per nulla impressionante, un metro e settanta di altezza, neppure 75 chili di peso. Ma si trattava di un’illusione ottica, perché la struttura fisica di Edson Arantes do Nascimento era invece l’assoluta perfezione: gambe ipertrofiche, potenza in ogni gesto e insieme agilità, equilibrio sublime. Qualcosa di esplosivo ed elastico. E poi la tecnica mostruosa, il dribbling, unico al mondo, la precisione nel tiro e l’elevazione per i colpi di testa, la visione di gioco che gli permetteva ogni volta di celebrare due partite insieme, contemporaneamente, una al servizio dell’altra: la sua e quella della squadra, cioè il Santos in maglia bianca oppure il meraviglioso Brasile. Mai nessuno così, mai più. Ci ha lasciato dopo un’agonia lunghissima, eppure ne siamo stupefatti.
Pelé, le vittorie e i gol
Può esserci un mondo senza Pelè? Artista e comunicatore istintivo, senza però l’aura maledetta di un Maradona che per sempre gli contenderà il giudizio di mezzo genere umano: meglio Pelè o Diego? Risposta impossibile, è come dover scegliere tra Leonardo e Michelangelo. Pelè è arrivato prima, in un calcio diversissimo e non ancora mondializzato. È rimasto sempre in una squadra sola (a parte i Cosmos), non ha conosciuto l’Europa, se non nelle vittoriose trasferte della nazionale. Si è mosso dentro una maggiore lentezza generale del gioco, però ha mostrato gesti, azioni, momenti e reti che nessuno aveva mai conosciuto sul pianeta Terra. La sua bellezza non ha confronti, i suoi 1.281 gol in 1.363 partite resteranno irraggiungibili anche per un Messi, la divinità contemporanea. Probabilmente nessuno, come Pelè, vincerà un mondiale a 17 anni, segnando tre volte in semifinale (contro la Francia) e due volte nella finale con la Svezia di Liedholm: memorabile il primo gol, pallonetto sulla capoccia del difensore e rasoterra al volo a fulminare il portiere. Era il 1958. Una cosa del genere, però moltiplicata per tre, Pelè la ripeterà il 2 agosto dell’anno seguente, in campionato, contro il Clube Atlético Juventus: addirittura tre “sombreri” (le palombelle volanti, appunto) prima del tiro. Siccome non esiste il filmato di quella prodezza che Pelè considerava la più grande di tutta la sua vita, un bel giorno ne venne realizzata una ricostruzione virtuale, cioè un’animazione al computer richiesta proprio da lui.
Pelé, genio del calcio
Tutto, in quest’uomo, è stato leggenda e narrazione, comprese le parole degli avversari. “Prima di affrontarlo nella finale del ’70 – ricordò l’azzurro Burgnich – mi ripetevo che anche Pelè era fatto di carne e ossa, come tutti. Ma sbagliavo”. Quella carne che non era solo carne e quelle ossa – forse cave, come negli uccelli – al minuto diciotto di Italia-Brasile si librarono in volo. Pelè decolla, il povero Burgnich assiste, simbolo della pesantezza del mondo quanto quell’altro era ormai angelico, più un’ascensione che una semplice elevazione. Pelè segnerà di testa, restando come immobile lassù, immagine di eterna eppure dinamica fissità. Da bambino faceva il lustrascarpe a Bauru, e lo prendevano in giro perché era proprio piccolo. Giocava a pallone (erano calzini riempiti di carta, qualche volta pompelmi) e si rivolgeva a un portiere di nome Bilè storpiandone il nome, chiamandolo invece “Pilè” come spesso fanno i bimbi nelle loro lallazioni che sono fonemi astratti, puro e magico suono che soltanto per loro ha senso. I compagni di gioco presero a canzonarlo, Pilè divenne Pelè, vocabolo che non diceva nulla, destinato però a contenere un universo, la storia di uno sport e di un uomo fantastico. Lui, veramente, non amò mai quel suo battesimo, avrebbe preferito farsi chiamare Edson o meglio Edison, il genio che inventò la lampadina e che suo padre Dondinho, calciatore non memorabile, scelse come profetico modello per il figlio, creatore di luci non meno abbaglianti.
Pelé e tre Mondiali vinti col Brasile
Nessuno ha mai vinto tre mondiali come Pelè. Allora, dal ’58 al ’70, si chiamava ancora Coppa Rimet, era una vittoria alata, una figuretta d’oro. Per nessuno prima di lui fu creato un videogioco, nessuno fu nominato “tesoro nazionale” dal governo per evitare che qualche club lo portasse via, e tra gli altri ci provò anche la Juventus. E’ stato un pioniere in America, con i Cosmos che forse non erano solo un’americanata, è stato ministro brasiliano dello sport, si è battuto contro alcol e droga dopo i guai e l’arresto del figlio Edinho. Ha vissuto storie sentimentali oscure, con una figlia nata fuori dal matrimonio e riconosciuta solo grazie al test del Dna con un triste corollario di alimenti non pagati ai nipoti, solo in questo simile al suo “nemico” Maradona, gemello dagli opposti destini. Ma mentre Diego è diventato nel tempo una sorta di bizzarro rivoluzionario contro svariati poteri, Pelè ha preferito essere uomo di istituzioni e sponsor. Metteva un po’ di tristezza guardarlo andare in giro con lo stemma di una carta di credito cucito sul taschino della giacca, ma niente avrebbe comunque potuto offuscare il fulgore della sua arte, le tinte nitide e calde della sua bellezza calcistica, neppure in tempi di mercato feroce.
Pelé e l’amore per il calcio
Pelè ha fatto parte del sistema, forse sapendo di restare eternamente un pezzo unico. Sugli autografi scriveva “do amigo” prima di quel bisillabo meraviglioso, il bizzarro suono nato per scherzare un bimbo. Per incontrare Pelè in situazioni ufficiali e intervistarlo, occorreva mettersi in lista con mesi di anticipo, entrando nelle grazie della carta di credito di cui sopra. Poi si veniva ammessi (una volta sola, sia chiaro) insieme a una ristrettissima schiera di eletti, di solito nella sala d’onore di un grande albergo. Ci si metteva seduti in cerchio, restando in silenzio in attesa del sovrano, finché la porta si spalancava. E in quel preciso momento ti accorgevi di non essere mai stato così emozionato in tutta la tua vita.