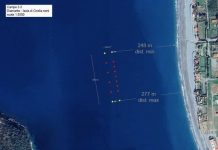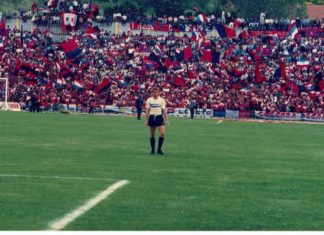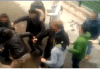Il culto della Madonna della Consolazione dell’Eremo, si fa risalire ad una famiglia genovese che tra la fine del 1400 e l’inizio del 1500 si trasferì a Reggio Calabria portandovi un’immagine di questa Madonna, lla quale era molto devota.
Per custodire questo quadro, fu costruita una cappelletta sulla collina detta “La Botte”, e i terziari francescani ne ebbero la custodia (i terziari furono detti Romiti e da qui il nome di Eremo al luogo che accoglieva la cappella).
In seguito alla venuta dei Cappuccini a Reggio, la custodia del quadro fu affidata ad essi.
Nel 1547 il pittore reggino Niccolò Andrea Capriolo riprodusse, per incarico del nobile Camillo Diano, la primitiva immagine della Madonna, in un quadro di dimensioni notevolmente maggiori, e vi inserì le figure di S. Antonio e S. Francesco.
Il quadro originario venne trattenuto dalla famiglia Diano e di questo si persero le tracce in occasione del suo trasferimento a Malta.
Nel 1569 sorge la prima chiesa sulla collina dell’Eremo e il culto si diffonde.
Negli anni successivi tante calamità minacciano la popolazione: terremoti, assalti dei Turchi, pestilenze gravissime, ma Reggio è sempre salvaguardata perla protezione di Maria che viene invocata con tanta fede e che, nei momenti di maggior pericolo viene portata in città, facendola scendere dal suo Eremo.
Già nel 1576 i Reggini avevano proclamato Maria della Consolazione patrona della città, nel 1752 se ne conferma solennemente il patrocinio.
Il terremoto del 1908 distrugge la chiesa dell’Eremo e il convento che, subito dopo, vengono ricostruiti in maniera provvisoria. Solo nel 1965 viene inaugurato il nuovo santuario, fatto costruire da Mons. Giovanni Ferro.
La festa della Madonna della Consolazione ricorre la seconda domenica di settembre.
Nei tempi più antichi i festeggiamenti cominciavano col primo dei sette sabati precedenti la data stabilita.
Gran parte della popolazione si recava all’Eremo per onorare la Vergine nel suo santuario.
Nella mattinata la città era animata dal suono dei tamburi, mentre a sera era illuminata tutta da luci sospese ai balconi e da fuochi pirotecnici chiamati “palombelle”. Ciò avveniva anche per tutti i sabati successivi, fino a che si arrivava alla festa.
Venditori di giocattoli, di cappelli, di vasellame arrivavano da fuori e schieravano la oro merce nelle piazze e lungo i due lati del corso.
In particolare la piazza Vittorio Emanuele veniva occupata da questi venditori.
Ad una estremità del corso si poneva un rande dipinto, che la sera veniva illuminato, che mostrava alcuni dei più celebri prodigi della Madonna.
Il venerdì precedente il primo giorno della festa, il santuario diventava meta di una gran quantità di gente che da posti vicini e lontani arrivava cantando e suonando.
Spesso al suono si univa la danza sul sagrato del Santuario.
Per tutta la notte era un continuo movimento: lucerne e fuochi di legna illuminavano i posti di vendita di bibite, frutta e ltri cibi, mentre una gran folla di gente cantava, suonava, ballava.
All’interno del Santuario l’immagine di Maria era vegliata dai fedeli in preghiera, tra centinaia di ceri ardenti.
La mattina di sabato, tutta la gran folla accompagnava Maria che lasciava il suo Eremo per raggiungere la città.
Reggio accoglieva la sua patrona in un’atmosfera di gran festa: alle due estremità del corso si ponevano due archi di trionfo che venivano, la sera, illuminati ad olio (questi stavano ad indicare le due antiche porte della città: porta Mesa e porta S. Filippo).
Mentre gli strati sociali più modesti accompagnavano a piedi (a volte a piedi nudi, per grazia ricevuta)la Madonna, le classi nobili e ricche sfilavano sulleloro carrozze, che, per l’occasione, venivano infiorate mirabilmente.
Un’altra usanza particolare era la consegna della sacra Immagine, da parte dei cappuccini al clero reggno; questa avveniva alla fine della via Cardinale ortanova, alla presenza di un notaio che stipulava n vero e proprio atto di consegna.