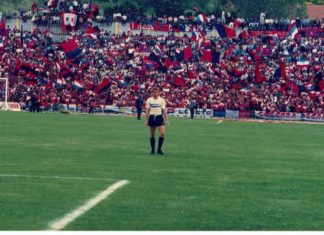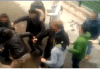Mentre l’Italia è stretta nella morsa di un’ondata di calore, e da Nord a Sud si rinnovano gli appelli all’uso responsabile dell’acqua a causa dell’allarme siccità, i nostri fiumi vengono prosciugati da industrie “idrovore” che producono l’energia elettrica necessaria a rinfrescare le nostre città sempre più bollenti. Così facendo, a perdere è l’ambiente e la produttività nazionale.
di Matteo Olivieri
In un articolo de IlSole24Ore del 4 agosto 2017 si legge che «secondo gli esperti, per ogni grado in più sopra la temperatura di 25 gradi la domanda elettrica cresce tra 800 e mille megawatt (Mw)». L’equivalente di una centrale termoelettrica. E di centrali termoelettriche in Calabria ne abbiamo già 5, rispettivamente a Simeri Crichi (857 Mw), Altomonte (780 Mw), Scandale (802 Mw), Rizziconi (760 Mw) e Rossano (1.738 Mw, in dismissione). Tutte hanno bisogno di acqua, molta acqua, per raffreddare gli impianti che producono elettricità. In alcuni casi, come a Simeri Crichi, l’acqua è prelevata dal mare e dissalata; in altri casi, come ad Altomonte, si usa l’acqua di falda e l’acqua dell’acquedotto.

Si tratta di una scelta insana e costosa, se si considera che il territorio in questione ha una elevata vocazione agricola, a motivo delle numerose produzioni agroalimentari di qualità, che entrano in competizione con la centrale termoelettrica per l’utilizzo della falda acquifera. Infatti, in base agli ultimi dati ufficiali disponibili sulle prestazioni ambientali (certificati in base alla normativa europea EMAS), sappiamo che nel 2015 la centrale di Altomonte ha consumato 41.512 m3 di acqua prelevata dal pozzo, e 512 m3 di acqua prelevata dall’acquedotto. Ma nel 2013, in seguito al verificarsi di una «perdita», si dovette ricorrere in maniera massiccia all’uso di acqua potabile dell’acquedotto per raffreddare gli impianti, e i consumi idrici della centrale triplicarono, arrivando a toccare i 1.473 m3, a fronte di un utilizzo di “appena” 25.711 m3 di acqua dal pozzo per produrre 1.406.675 Mw di energia. Sempre dalla certificazione EMAS sappiamo che «l’entità dell’emungimento dalla falda idrica sotterranea ad Altomonte è pari a 10 m3 all’ora», mentre «l’impianto è autorizzato a prelevare fino a 90.000 m3 di acqua di falda all’anno». Si tratta di una massa impressionante di acqua, che ovviamente viene tolta ad altri utilizzi (tra cui l’agricoltura ed il consumo privato), e del cui utilizzo si sente parlare poco, se non per le frequenti proteste delle popolazioni locali che lamentano la persistente carenza d’acqua per usi privati.

Quando venne posata la prima pietra nel 2002, si disse che la centrale «produrrà oltre 5 miliardi di chilowattora all’anno, una quantità di energia sufficiente, per esempio, a coprire il fabbisogno domestico di tutte le famiglie di una regione come la Sicilia». Ad oggi invece siamo a circa 2,7 miliardi di chilowattora (2015), una quantità più che doppia rispetto al 2014 quando i chilowattora furono 1,2 miliardi. Noi sappiamo che l’utilizzo di acqua è proporzionale al numero di ore di funzionamento dell’impianto e dalla produzione di energia elettrica, quest’ultima che a sua volta dipende dalla domanda di energia elettrica nazionale.

Ovviamente, nel periodo estivo il consumo elettrico aumenta vertiginosamente, sia in termini di volume che di prezzo di vendita. Giusto per fare un termine di paragone, secondo gli ultimi dati forniti da Terna(la società che gestisce la rete elettrica nazionale), nel mese di giugno 2017 la domanda di energia elettrica in Italia è stata di 27,2 miliardi di kWh, in aumento del 7,6% rispetto ai volumi dello stesso mese dell’anno precedente. anche le quotazioni dell’energia elettrica sono in rialzo, con punte che – in questi giorni – superano facilmente i 100 euro a chilowattora rispetto ai 48 del mese di giugno.
Così, mentre si rincorre il business dell’energia, i fiumi calabresi rimangono a secco. Secondo i dati Terna (2015), le regioni con maggiori surplus di produzione totale di energia elettrica rispetto alla richiesta sono la Puglia (+17,8 TWh), Calabria (+8 TWh), Trentino (+4,1 TWh) e Sardegna (+2,7 TWh),mentre quelle con maggiori deficit sono la Lombardia (-26,6 TWh), Veneto (-12,7 TWh), Emilia Romagna (-11,5 TWh) e Campania (-8,8 TWh) (dati di ottobre 2016).
Poco si sa su come le risorse idriche vengano effettivamente gestite a livello regionale, mentre a livello nazionale sappiamo che l’aumento della domanda di energia elettrica è stato soddisfatto per l’89,6% mediante produzione nazionale e per la quota restante (10,4%) dalle importazioni estere. In particolare, per quanto riguarda la produzione nazionale, è aumentato il ricorso alle fonti di produzione termica (+26%) e fotovoltaica (+8,7%), mentre sono in flessione le fonti di produzione geotermica (-1,7%), eolica (-18,7%) e idrica (-19,8%). Questo vuol dire, che tanto più continuerà ad aumentare la domanda di energia elettrica, tanto più gli attuali impianti termoelettrici aumenteranno la produzione e, con essa, il consumo di acqua.

L’energia elettrica non si può immagazzinare. E’ quindi necessario produrre in ogni istante la quantità di energia elettrica richiesta dal mercato (sia per quanto riguarda i consumi familiari che per usi industriali), facendo in modo che ci sia sempre equilibrio tra domanda e offerta, in modo da garantire la continuità nella fornitura del servizio. A perdere però è l’ambiente e, con esso, la biodiversità degli ecosistemi della nostra terra, che pur essendo particolarmente ricca di acqua, si ritrova in uno stato di grave carenza idrica, non solo a causa delle minori piogge, ma anche per colpa di scelte politiche sbagliate, che consentono il sovrasfruttamento delle falde acquifere, e così facendo svendono il capitale naturale della Calabria ed il futuro di questa terra, nel tentativo di rincorrere il miraggio di uno sviluppo economico che non solo non si intravede, ma che rema contro gli stessi interessi dei calabresi.