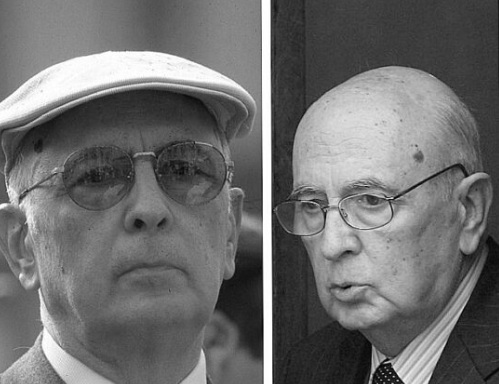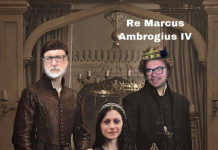La salita al Colle – Senatore a vita dal 2005 (lo ha nominato Carlo Azeglio Ciampi), dopo essere stato presidente dei deputati comunisti (1981-1986), parlamentare europeo in due legislature (1989-1992 e 1999-2004), presidente della Camera (1992-1994) e ministro degli Interni nel governo Prodi (1996-1998), Napolitano nel 2006 è, ufficialmente, fuori dai giochi (ha aderito al Pds sorto dopo lo scioglimento del Pci, pur non apprezzando granché le vaghezze e le irruenze di Achille Occhetto, e in seguito ai Ds). Un padre nobile senza particolari ambizioni, con una lunga vicenda politica alle spalle. Il suo nome viene buono a sinistra – l’usato sicuro – quando si sgonfia la candidatura di Massimo D’Alema al Quirinale. Lui accetta e al quarto scrutinio, con 549 voti su 990 votanti, viene eletto.
Troppi via libera al Caimano – La seconda fase della vita di Giorgio Napolitano comincia qui, e molto inchiostro è stato versato per ripercorrerla nei dettagli. Nel discorso di insediamento, dice come di consueto che rappresenterà tutti e che auspica un confronto civile e costruttivo fra maggioranza e opposizione (lo aveva già detto nel 1994, nella dichiarazione di voto sulla fiducia al neovincitore Silvio Berlusconi, ricevendone complimenti e strette di mano). Restando all’essenziale, ma i rilievi sono molto più numerosi di quelli che qui ricordiamo, secondo i critici il presidente è fin troppo accondiscendente con il Caimano: nel 2008 gli firma senza sollevare obiezioni il lodo Alfano sull’immunità delle alte cariche dello Stato (la Corte Costituzionale lo boccerà); nel 2009 firma la legge sullo scudo fiscale senza rinviarla all Camere e Di Pietro lo accusa di viltà; nel 2010 firma il decreto del governo per riammettere alle regionali della Lombardia e del Lazio le liste del Polo delle Libertà escluse per mancanza dei requisiti di legge; nel 2010 promulga la legge sul legittimo impedimento del capo del governo e dei ministri, contestata dai pm di Milano e ritenuta parzialmente incostituzionale dalla Suprema Corte. Lo accusano anche da destra di interferenza: come quando fa sapere a Berlusconi, nel febbraio 2009, che non firmerà il decreto per tornare ad alimentare Eluana Englaro, non ancora scritto ma annunciato. L’ira del centrodestra esplode soprattutto quando, nel 2011, costringe alle dimissioni un traballante Silvio Berlusconi, con lo spread alle stelle e l’Italia nel mirino degli speculatori, e affida l’incarico all’economista Mario Monti, che ha provveduto a nominare senatore a vita tre giorni prima: l’accusa è di colpo di stato dei “poteri forti” e se è tecnicamente infondata – il governo Monti ottiene una larga e insolita fiducia dal Parlamento – restano tuttavia agli atti le pressioni della Bce e delle cancellerie europee per un cambio di passo.
Trattativa e non solo: quei brutti rapporti coi pm – Ancora più controversi sono i rapporti di Napolitano con la magistratura. Nella sua veste di capo del Csm, il presidente interviene per stigmatizzare i magistrati fuori dal coro (Henry John Woodcock del quale chiede il fascicolo, Luigi De Magistris) e, soprattutto, solleva presso la Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione contro la Procura di Palermo che, nell’ambito delle indagini sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e la mafia, ha anche Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza. L’ex ministro della Dc telefonava spesso al Quirinale, soprattutto per parlare con Loris D’Ambrosio, consulente del Colle per le vicende inerenti alla giustizia. In quattro occasioni, però, Mancino parla anche direttamente con Napolitano. Quelle intercettazioni sono irrilevanti ai fini penali, la procura di Palermo ne avrebbe ordinato la distruzione nel corso di un’udienza stralcio in cui sarebbero stati presenti gli avvocati delle parti in causa, come prevede il codice di procedura penale. Ma Napolitano si impunta: le comunicazioni del presidente sono riservate e inviolabili, vanno distrutte senza che nessuno le ascolti, punto e basta. La Corte Costituzionale gli dà ragione ma i costituzionalisti si spaccano. Gustavo Zagrebelsky, ex presidente della Corte, lo critica aspramente e il penalista e scrittore Franco Cordero lo accusa di volersi ritagliare prerogative da monarca assoluto.
Il bis di Re Giorgio e le larghe intese – Nel 2013 Re Giorgio, esaurito il settennato, accetta di dare il bis e viene rieletto – è la prima volta nella storia della Repubblica – al sesto scrutinio, con 738 voti su 997 votanti. Proseguendo l’esperienza della larghe intese inaugurata con il governo Monti (nato dalla scelta di non sciogliere le Camere dopo la caduta di Berlusconi) e ignorando la novità politica di quegli anni, cioè il Movimento 5 Stelle (celebre, dopo il successo alle amministrative del 2012, la sua frase ai cronisti: “Di boom ricordo quello degli anni Sessanta, altri non ne vedo”). Così tiene a battesimo due governi compositi guidati da Enrico Letta e – “Enrico, stai sereno” – da Matteo Renzi. Poi nel 2015 la rinuncia e l’uscita di scena, con rari interventi da senatore a vita. Che cosa resta della sua lunga esperienza? Anche a evitare la polemica a tutti i costi, a scegliere di non affondare il coltello nella piaga, una lunga stagione spesa a normalizzare il Pci e a farlo entrare nell’arena del potere – “Veniamo da lontano, andiamo lontano” era un vecchio e fortunato slogan comunista – prima in nome dei ceti subalterni e poi, tramontato il sol dell’avvenire, in nome del senso di responsabilità. Il governismo che ha logorato la sinistra e il Pd non sarà tutta colpa sua, ma Napolitano non è stato privo di responsabilità. Come il gatto del Cheshire che in Alice si smaterializza e del quale prima di scomparire resta appena la chiostra dei denti, anche di quegli ideali è rimasto soltanto un sorriso. Un sorriso senza gatto.