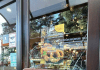Si tratta di due episodi per cui la Dda di Catanzaro, nell’ambito dell’inchiesta “Olimpo” contro i clan del Tirreno vibonese, non ha chiesto l’applicazione di misure cautelari, dunque il gip non ne fa menzione dell’ordinanza di custodia che ha coinvolto 56 persone (78 in totale gli indagati). Lo stesso giudice (Chiara Esposito) specifica però che la richiesta di misura vergata dai pm antimafia Andrea Buzzelli, Andrea Mancuso e Antonio De Bernardo si intende «integralmente richiamata e trascritta» per «completezza argomentativa». E proprio tra le oltre 4mila pagine della richiesta si parla delle «interazioni» che il clan La Rosa di Tropea avrebbe alimentato «con soggetti addentro al tessuto istituzionale, impiegati in delicati settori dell’apparato politico-amministrativo».
Tali sono il Tribunale e la Prefettura di Vibo, due pilastri dello Stato sul territorio in cui però, stando a quanto emerge dalla recente inchiesta, la cosca avrebbe in qualche modo allungato i suoi tentacoli. Il primo episodio riguarda un impiegato del palazzo di Giustizia vibonese, non indagato, che si sarebbe rivolto al presunto boss per risolvere una questione che turbava la sua famiglia. Il dipendente del Ministero della Giustizia, che all’epoca dei fatti (qualche anno fa) svolgeva mansioni in un importante ufficio del Tribunale, avrebbe ricevuto pressanti richieste di denaro da due giovani che dicevano di vantare un credito nei confronti di un suo congiunto. Si trattava, a suo dire, di richieste piuttosto intimidatorie, ma “prima di andare dai carabinieri” il dipendente del Tribunale avrebbe tentato una strada ritenuta più breve ed efficace, quella che lo aveva portato a chiedere l’intervento del presunto capo della ‘ndrina di Tropea, Antonio La Rosa. Parlandone proprio con lui e con il padre Domenico l’uomo pronuncia una frase eloquente: “Io con voi mi sono messo sempre a disposizione”. Incassando, per questo, le rassicurazioni di La Rosa: “No… ci mancherebbe… che mo non vediamo…”. I pm rilevano come si tratti di un caso emblematico di come “l’autorità”, a dispetto della rete istituzionale fosse riconosciuta al maggiorente della ‘ndrina.
L’OCCHIO IN PREFETTURA
L’altro caso riguarda una persona indagata a piede libero, Saveria Angiò, cognata del presunto boss e dipendente del Ministero dell’Interno: secondo la Dda avrebbe violato “i doveri inerenti alle funzioni o al servizio” rivelando a La Rosa “notizie d’ufficio che dovevano rimanere segrete, quali quelle riguardanti i precedenti giudiziari e lo stato delle pratiche pendenti in Prefettura relative ad alcuni esponenti della criminalità organizzata del Vibonese (tra questi certamente Salvatore Morelli, Graziella Silipigmi ed esponenti delle famiglie Pardea e Prostamo).
L’accusa formulata nei confronti della donna, in concorso con il cognato. è di rivelazione di segreti di ufficio con l’aggravante mafiosa. Sarebbe stata il loro “occhio” in Prefettura. I pm ipotizzano una sua “propensione/disponibilità” ad “assicurare una “sbirciatina” alla documentazione d’ufficio funzionale alle esigenze degli indagati”. Le indagini avrebbero consentito di “appurare come, forte delle aderenze in essere con i La Rosa, che pure si riproponevano di avviare azioni intimidatorie avverso i colleghi “scomodi” dell’indagata, la Angiò non si facesse scrupolo di attingere e traferire informazioni dalla documentazione d’ufficio dell’Utg di Vibo Valentia allo scopo di fornire al La Rosa Antonio utili precedenti che gli consentissero di meglio inquadrare – e quindi di gestire – la propria situazione di destinatario del provvedimento di revoca della patente, per mancanza dei requisiti morali, in funzione di vicende analoghe”. Fonte: Gazzetta del Sud